Sgobbare felici
Il lavoro fa ammalare, leggiamo di continuo. Non è del tutto esatto. Può essere invece una grande risorsa, purché ne siamo soddisfatti. Addirittura ci protegge anche dai disturbi mentali.

Negli ultimi anni il mercato del lavoro non ha dato spesso occasioni di ottimismo: «In crescita le malattie professionali», «Sovraffaticamento, stress, sindrome da esaurimento», denunciano i titoli dei giornali. Molti lamentano un eccesso di tensione e di fatica sul lavoro: il burnout è la malattia del giorno.
Aumenta di continuo anche il numero dei pensionamenti anticipati a causa di disturbi psichici, che in Germania ha fatto registrare ultimamente un nuovo record: il 41% delle richieste di congedo anticipato sono motivate da depressione o stati ansiosi. In effetti la situazione economica attuale ne è in buona parte responsabile.
A partire dai primi anni Novanta, infatti, dobbiamo fare i conti con un processo di trasformazione della società che si ripercuote soprattutto sul mercato del lavoro: globalizzazione e deregolamentazione selvaggia riducono le protezioni statali e la sicurezza dell’impiego. Si presume che, invece di poter contare su questi sostegni, ciascuno sia responsabile in proprio della sua riuscita personale e professionale: «C’è stato un cambiamento radicale, da un sistema sociale chiuso e vincolante ad uno aperto e in costruzione», spiega Heiner Keupp, psicologo sociale all’Università di Monaco. «Il rivolgimento è evidente soprattutto nel mondo del lavoro».
Inoltre, la situazione attuale, con i suoi ritmi vertiginosi, i carichi di lavoro crescenti e una flessibilità sfrenata, non pone più limiti e c’è il rischio di lavorare fino allo stremo, come bestie da soma. Non meraviglia che una rivista medica autorevole come il britannico Lancet titoli: «Business is bad for your health», «Lavorare fa male alla salute».
Ma questa è solo una mezza verità. È raro che il lavoro basti da solo a causare una sindrome di burnout o addirittura una malattia mentale. La salute è piuttosto un processo che dipende da molti fattori: non solo il carico di lavoro, la retribuzione e il riconoscimento, ma la storia personale, l’attuale situazione di vita, l’integrazione sociale.
Per queste ragioni Hans-Peter Unger, primario del centro di salute mentale dell’Asklepios-Klinik del distretto di Harburg, ad Amburgo, autore con Karola Kleinschmidt di un best-seller sull’argomento, Quando il lavoro ci fa ammalare, suggerisce una visione più differenziata: «Il dibattito sul burn-out a mio avviso è troppo focalizzato sulle condizioni di lavoro come unica causa del problema.
È un discorso vecchio. Il lavoro è un fattore importante della nostra vita, non fa solo male alla salute. Anche la fatica è parte integrante dell’esistenza. Molto più importante è mantenere un equilibrio, oggi che la cura di sé non è più un aspetto ritualizzato della vita, in un mondo dove i confini fra lavoro e tempo libero, fra pubblico e privato, sono sempre più fluidi».
Non è vero, quindi, che ci si ammala di lavoro? Forse tutta la discussione sulla sindrome di burn-out, per quanto giustificata, ha distolto lo sguardo da un aspetto importante, cioè gli effetti salutari del lavoro. Perché un buon lavoro, oltre a una remunerazione adeguata, offre anche molte esperienze positive, come struttura, riconoscimento, scambi sociali, senso di efficienza, e può rappresentare quindi una risorsa importante. «L’attività professionale è un elemento del tutto centrale del nostro vissuto e contribuisce in maniera decisiva alla salute mentale», osserva anche Steffi Riedel-Heller, direttrice all’Università di Lipsia dell’Istituto per la medicina sociale e del lavoro e le politiche sanitarie. «Questo aspetto negli ultimi anni è caduto nel dimenticatoio. Ma una società fa bene se permette ai suoi membri di vivere come un contributo utile e importante quello fornito con il loro lavoro. Per questo dovremmo considerare con più attenzione quali risorse psicologiche si possono ricavare dall’attività produttiva».
Non è facile definire in blocco cos’è il lavoro buono. Perché dipende dalla rispondenza fra l’individuo e l’attività, se questa farà bene o male alla salute. Le competenze che permettono a una persona di affrontare questo o quel compito dipendono in ultima analisi dalla sua disposizione biologica e dalla sua costituzione psicofisica. Così una bibliotecaria amante della tranquillità non si troverà affatto bene nell’ambiente frenetico di un call-center, come un medico con la vocazione degli interventi di emergenza non accetterebbe mai volentieri un lavoro a tavolino in un istituto di ricerche farmaceutiche. «Esigenze lavorative che sono stressanti per una persona possono rappresentare per un’altra sfide stimolanti», osserva Steffi Riedel-Heller, che nel suo Istituto studia la correlazione fra salute mentale e curriculum lavorativo.
È possibile tuttavia indicare sei ambiti da cui dipende se un dato impiego è favorevole o sfavorevole alla salute fisica e mentale: il carico di lavoro, l’ambiente di attività, il riconoscimento, il senso di comunità, la giustizia e i valori.
Riedel-Heller sostiene che: «Se il carico di lavoro risulta sopportabile e il singolo ha possibilità di scelta e un certo grado di controllo, un gruppo che lo sostiene, adeguato riconoscimento e remunerazione, in un clima di rispetto, correttezza e giustizia sociale, e sente che il suo lavoro è dotato di senso e rispondente ai suoi valori, può svilupparsi un tipo d’impegno molto positivo per il benessere psicologico».
In altre parole, un buon lavoro può dare stabilità e aiutare a sopportare meglio le tensioni in altri aspetti della vita quotidiana. Non solo, ma gli effetti positivi si prolungano anche negli anni della pensione. Studi recenti dell’Istituto guidato da Riedel-Heller dimostrano che le attività professionali che comportano una complessa interazione con dati e con persone e favoriscono una programmazione autonoma dell’attività riducono il rischio di demenza senile. «Abbiamo dati che indicano un calo tendenziale del tasso di demenza in Nord Europa», nota la psichiatra. «Crediamo che ciò non dipenda solo da miglioramenti dello stato cardiovascolare (le persone fumano e bevono meno di prima), ma anche dal fatto che il nostro ambiente di lavoro è diventato più stimolante sul piano mentale. Può darsi che anche cose generalmente connotate in negativo, come l’uso crescente dei nuovi media, abbiano un’influenza positiva, perché rappresentano una sfida che stimola il cervello e quindi lo mantiene efficiente».
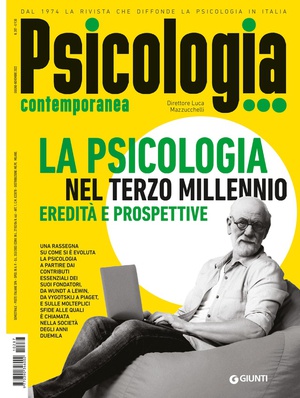
In effetti sembra che molti considerino il posto di lavoro come una risorsa positiva. Un recente sondaggio dell’Istituto di Ricerche Demoscopiche Internazionali YouGov, su un campione rappresentativo di 1000 lavoratori tedeschi, ha accertato che il 75% è contento del proprio lavoro. La possibilità di affrontare sfide nuove, la varietà delle mansioni quotidiane e la prospettiva di un buono stipendio hanno particolare importanza per la soddisfazione professionale.
Per il 14% degli intervistati è inoltre importante l’idea di fare “qualcosa di utile” per la società. Appena il 7% si dichiara decisamente insoddisfatto del suo impiego. A un risultato simile giunge uno studio recentissimo dell’Istituto di Economia di Colonia, che mostra come la metà circa dei tedeschi sia “altamente soddisfatta” della propria vita. A questa valutazione positiva contribuiscono, secondo gli autori, soprattutto la salute e il fatto di avere un posto di lavoro: l’indice di soddisfazione generale, infatti, è più alto del 20% in media fra gli occupati che fra i disoccupati.
Non il lavoro, quindi, ma la sua mancanza compromette la soddisfazione delle persone. Il rapporto sulla salute pubblicato nel 2014 dalla DAK (Deutschen Angestellten-Krankenkasse) mostra in modo chiaro che lo stress cronico colpisce soprattutto i disoccupati e le madri sole: «Non è il manager superimpegnato a soffrire di più le conseguenze dello stress, ma la studentessa, la madre sola e il disoccupato», chiarisce Thomas Bodmer, membro del consiglio d’amministrazione della DAK.
Queste conclusioni si basano su un questionario che la DAK ha sottoposto a un campione di associati fra i 25 e i 40 anni. È risultato che quanto più basso era lo status, tanto più alto era lo stress: più alto fra gli impiegati intermedi che fra i dirigenti, ma soprattutto a soffrirne erano le madri sole e gli studenti. A quanto pare, più di un lavoro “stressante” pesano le preoccupazioni economiche, l’incertezza per il futuro e la scarsa considerazione che si accompagna alla disoccupazione.
Infatti nel disoccupato non pesa soltanto il disagio economico, ma anche il fatto di sentirsi inutile: alcuni studi dimostrano che, a parità di reddito mensile, stato di salute e livello d’istruzione, i disoccupati sono nettamente più infelici degli occupati. Senza contare l’interazione ben dimostrata fra disoccupazione e disturbi psichici: il disoccupato ha statisticamente un rischio maggiore di sviluppare turbe mentali, e viceversa la disoccupazione aggrava le condizioni dei malati di mente. Non sorprende quindi che molti disoccupati siano alle prese con problemi psichici. Secondo uno studio recente dell’Istituto per il mercato del lavoro e la ricerca occupazionale, dell’Agenzia federale del lavoro, in Germania fra i titolari di un sussidio di disoccupazione uno su tre presenta una turba mentale diagnosticata.

Questo articolo è di ed è presente nel numero 253 della rivista. Consulta la pagina dedicata alla rivista per trovare gli altri articoli presenti in questo numero. Clicca qui


