L’importanza dell’ascolto del paziente dalla psichiatria alle neuroscienze cliniche
La psichiatria, da branca della medicina che si occupa della cura dei disturbi mentali, si è estesa alla salute comportamentale. L’ingresso della biologia e delle neuroscienze nello studio della relazione mente-cervello non deve però far dimenticare l’importanza di instaurare una relazione paritaria con il paziente.

PERCHÉ LA COMUNICAZIONE MEDICO-PAZIENTE È FONDAMENTALE
Nanni Moretti, nel terzo episodio del film Caro diario, in cui racconta la sua esperienza personale con i medici, conclude piuttosto sconsolato: «I medici sanno parlare ma non sanno ascoltare». Una considerazione che fa riflettere e dispiace, soprattutto in un momento in cui la gran parte dell’assistenza viene a realizzarsi nelle angustie spazio-temporali dell’emergenza o in un ambulatorio in cui spesso lo schermo di un computer si intromette, rendendo veramente difficile la comunicazione tra medico e paziente. Di questa riduzione, chi si occupa dei disturbi del comportamento, e di quelli che sino ad oggi ancora vengono chiamati disturbi mentali, soffre ancora di più.
Tutt’oggi la definizione di psichiatria è tradizionalmente la seguente: «quella branca della medicina che si occupa della cura dei disturbi mentali». Ma con l’allargamento del campo delle conoscenze degli ultimi anni si è estesa all’area della salute comportamentale (Pallanti, 2020) e si cominciano a distinguere al suo interno numerose branche specialistiche. Una di queste specialità è quella della “terapia della parola”, dell’ascolto partecipe. All’interno della medicina, lo specifico di tutte le discipline che iniziano con il prefisso “psi” è l’attenzione all’esperienza soggettiva della malattia: il racconto in prima persona del paziente che lo specialista deve ascoltare, stimolare, ampliare, approfondire e interpretare.
L’attenzione a questa fase di ascolto, rivolta al messaggio verbale e in buona parte a quello non verbale così come riferito dalla persona sofferente, si è molto evoluta. Mentre si crede che la ricerca biologica sul cervello abbia ridotto lo spazio per l’indagine narrativa della sofferenza mentale, è vero invece il contrario; mai come oggi si deve fare riferimento all’esperienza di prima mano del paziente, sia nel momento della definizione della diagnosi sia durante la terapia. Questo proprio perché la ricerca ha evidenziato quanto ogni individuo vada considerato nelle sue particolarità affinché la cura possa essere personalizzata, od orientata alla persona anziché genericamente orientata alla malattia. L’avvento dell’approccio basato sulle neuroscienze non soltanto ha mantenuto tale principio, ma ha inoltre valorizzato la persona, perché introducendo nella valutazione anche alcuni dati neurobiologici è richiesto un ampliamento della cultura dello psichiatra e delle sue capacità traslazionali. “Traslazione” è un termine che descrive la pratica di trasferire la conoscenza scientifica “dal laboratorio al letto del paziente” (B2B, “from bench to bedside”): la medicina traslazionale si fonda sui progressi della ricerca di base e sugli studi dei processi biologici che sottendono ai disturbi evidenti a livello comportamentale.
Dobbiamo aumentare la capacità di ascolto in modo da poter aiutare nelle fasi precoci del disturbo, quando il soggetto inizia a percepire che le cose non vanno, anche in assenza di sintomi evidenti, e in questo modo prevenire gli effetti della neuroplasticità disfunzionale del disturbo che avanza e diventa pervasivo. Bisogna quindi continuare ad ascoltare, mettendo in sintonia l’esperienza, ma – è questa la maggiore novità – anche tutte le conoscenze tecnico-scientifiche; ascoltare, ovvero dare la massima importanza a ciò che la persona ci comunica.
Non è sempre stato così; all’inizio, quando ancora si generalizzava e si squalificava la sofferenza mentale sotto l’ombrello del termine “follia”, ciò che diceva il “malato di mente”, il folle, era vaniloquio, farneticazione priva di senso alcuno, e pertanto le sue parole non erano degne di essere considerate se non come sigillo di pazzia. Dando ordine al campo e cominciando a distinguere tra le diverse specie di follia, si cominciò a riconsiderare le parole del malato di nervi e a distinguere tra “confusione mentale”, dovuta al trauma o all’infezione, e delirio come segno tipico della psicosi.
Contemporaneamente e specularmente alla ridefinizione del tipo di ascolto, la figura del guaritore ha cambiato fisionomia e definizione. L’alienista, infatti, viene sostituito dallo psichiatra via via che si inaugura l’introduzione di veri interventi terapeutici che non siano semplicemente contenitivi: più spazio alle cure vuol dire più spazio all’ascolto.
Gli alienati, i lunatici, finivano per essere isolati e allontanati dal consorzio civile perché i loro comportamenti non contaminassero i benpensanti e perché non rappresentassero un pericolo per sé e per agli altri. Così è stato almeno fino agli inizi del Novecento, quando il racconto della sofferenza mentale iniziò ad assumere un nuovo significato. Fino a quando Carl Gustav Jung non si avventurò nell’interpretazione psicologica della psicosi, i deliri e le allucinazioni rappresentavano solo l’emblema della follia ed erano privi di validità comunicativa. È con l’arrivo della psicoanalisi, in primis grazie a Freud e al suo “meraviglioso Schreber” con le sue Memorie di un malato di nervi, che ciò che il malato dice si apre all’interpretazione psicologica, tanto che si inizia a dare ascolto perfino ai racconti dei sogni, resoconti che fino ad allora erano stati appannaggio dei chiaroveggenti. La stessa psichiatria si arricchisce di un nuovo atteggiamento di ascolto: la fenomenologia applicata.
Negli stessi anni, Eugen Bleuler afferma che non è la “de-menza” il centro della psicosi, ma la “scissione”, il processo mentale al nucleo della schizofrenia, e comincia a distinguere tra i sintomi primari legati al cervello malato e quelli secondari legati a come la persona riesce a porsi di fronte ai disturbi e a riferire di essi. La fenomenologia in questa accezione diviene una metodologia di ascolto che, attraverso lo strumento dell’immedesimazione, in cui chi ascolta si mette nei panni dell’altro, apre alla comprensione dell’esperienza vissuta dalla persona sofferente.
L’ASCOLTO DEL PAZIENTE
Non si ascolta “dall’alto della normalità”, ma ponendosi allo stesso livello del paziente; prima di tutto, cercando di astenersi da ogni giudizio, soprattutto moralistico: il malato va anzitutto compreso e solo in seguito si proverà a distinguere le esperienze riportate tra quelle per così dire “normali”, quindi condivisibili, e quelle “anomale”, quindi spiegabili unicamente se considerate come espressione di una distorsione, di un’esperienza esistenziale alterata o fallita.
La fenomenologia dava così ai pazienti una voce che poteva essere ascoltata e, successivamente, la psicoanalisi si accorgeva di altre forme, per così dire “minori”, che nella vita quotidiana, in scala ridotta, con piccoli segnali dell’irruzione dell’inconscio, procuravano infrazioni che non producevano il totale inabissamento del fluire della coscienza caratteristico della psicosi, ma solo una specie di “cavità carsica”: la nevrosi.
Con l’inizio dello studio del funzionamento del cervello, auspicato da Freud, si apre l’era delle neuroscienze e il modello puramente mentale della sofferenza psichiatrica diventa più articolato e complesso.
Perché? Perché l’interpretazione rimandava semplicemente all’esperienza biografica del soggetto, mentre alla luce delle scoperte più recenti si evince come il clinico debba fare l’ulteriore sforzo di cercare di capire ciò che il paziente non riesce a dire, perché il racconto è tracciato biologicamente nel sistema immunitario e nei meccanismi della plasticità del cervello, per lo più senza che il soggetto ne abbia consapevolezza.
Per fare un esempio: la ricerca biologica ha mostrato come l’esperienza drammatica dei campi di concentramento produca modificazioni epigenetiche che vengono sperimentate anche nella progenie, che pur essendone inconsapevole, ne sperimenterà la stessa orrenda precarietà (Dashorst et al., 2019).
Come? Attraverso una suscettibilità a sviluppare emozioni e affetti negativi che danno significato al presente: le emozioni sono il sapere di cui non sappiamo.
LE NEUROSCIENZE
Per chiarezza fornirò quindi una definizione precisa del termine “neuroscienze” per poi spiegarne le conseguenti novità. Il termine venne utilizzato per la prima volta dal biologo molecolare Francis O. Schmitt che, presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT), introdusse il neologismo “neurosciences” per definire un programma, il Neurosciences Research Program, teso alla comprensione dei meccanismi del funzionamento cerebrale e dell’attività mentale. Schmitt aveva intuito che le sole scienze neurologiche, e quindi il limitarsi a indagare il cervello o dentro il cervello, non sarebbero state sufficienti ad ampliare realmente la comprensione dei meccanismi cerebrali.
Il gruppo di ricerca venne costituito da scienziati di diversa formazione: matematici, fisici, chimici, ma anche esperti in nanotecnologie, ingegneria, informatica, psicologia, medicina, biologia e filosofia. Quindi, le neuroscienze non sono le scienze neurologiche, e neanche soltanto le scienze che studiano il cervello e il suo funzionamento, come per lo più molti ancora intendono. Le neuroscienze sono un insieme di discipline scientifiche che hanno in comune l’intento di comprendere l’organizzazione e il funzionamento del cervello tramite l’utilizzo di tecniche diverse.
Le neuroscienze rappresentano un approccio alla conoscenza che, come indicato da Max Black, funziona come una metafora interattiva. In base a ciò, esse consentono di guardare in contemporanea al cervello e a un dominio che, con quest’ultimo, abbia un rapporto di isomorfismo strutturale. In tal modo, il vissuto raccontato dal paziente consente di gettare luce (enlightment) tanto sul funzionamento del suo cervello quanto sulla sua esperienza esistenziale.
L’ESPERIENZA SOGGETTIVA: IL VISSUTO
Il “vissuto”, l’esperienza soggettiva, ha avuto vicende alterne. Gli anni Sessanta lo portarono alla ribalta, collocandolo al centro della psichiatria. In La politica dell’esperienza – L’uccello del paradiso, Ronald David Laing valorizza il “vissuto” soggettivo e critica il concetto di “devianza” dalla normalità. Con un ribaltamento copernicano, l’idea di normalità tipica della società moderna diventa mero conformismo, atteggiamento falso e da demolire. Ciò dette sostegno all’idea che fosse il mondo ad essere malato, non le singole persone; la psicosi venne interpretata come un «viaggio psichedelico di scoperta in cui i confini della percezione e la consapevolezza sono allargati». Lo scritto finale del volume, L’uccello del paradiso, è ispirato all’esperienza di Laing stesso riguardo agli effetti derivati dall’assunzione di LSD. Non a caso, tra gli anni Sessanta e Settanta, la cultura psichedelica si poneva come difesa contro il perturbamento della falsità e di quel mondo che il soggetto vulnerabile costruisce per proteggersi: un “falso Sé” che mostra agli altri, ma anche a sé stesso. La psicopatologia, quindi, si pone da un lato come “modo di vivere” autentico, mentre dall’altro lato, con le prime applicazioni della ricerca biologica, diventa espressione evidente dell’alterata biologia del cervello.
Il celebre volume di Nancy Andreasen (The broken brain: The biological revolution in psychiatry, 1985) illustra come la schizofrenia sia l’espressione di un cervello che non funziona più, dichiarando superata la visione puramente mentale della malattia. Ma fu poi la stessa Andreasen ad auspicare il ritorno all’ascolto fenomenologico e a chiedere un aiuto proprio agli psicopatologi europei. In sintesi, che cosa significa considerare la psichiatria come neuroscienza clinica? In cosa si distingue dalla psichiatria sociale, psicodinamica o puramente fenomenologica? La differenza è semantica: sono i significati della sofferenza che devono essere interpretati non solo in relazione agli eventi o alle situazioni in cui accadono o unicamente per il modo in cui vengono vissuti, ma anche in relazione ai correlati biologici che oggi documentiamo con le neuroscienze cliniche. Perché è nel cervello che si trova la rappresentazione della sofferenza, ed è a quella che le terapie devono fare riferimento, sia che siano neurobiologiche (farmaci, tecniche di stimolazione cerebrale ecc.) sia che si tratti di terapie della parola.
Sono queste le acquisizioni degli ultimi dieci anni: per esempio, quando la depressione diventa malattia, una specifica area del cervello – l’area 25 di Brodmann – è metabolicamente iperattiva e qualunque terapia si dimostri efficace agisce modificando questa iperattività. Ciò vale per la psicoterapia, che quando è efficace modifica il funzionamento cerebrale, ma anche per gli antidepressivi e per le nuove tecniche di stimolazione elettromagnetica del cervello. Questa posizione è sostenuta anche dal recente approccio allo studio delle malattie mentali RDoC, Research Domain Criteria, promosso dal National Institute of Mental Health, che ha spostato l’attenzione dalla cura dei sintomi ai circuiti cerebrali sottostanti. Eric Kandel, psichiatra e psicoanalista, cui è stato assegnato il premio Nobel per le sue ricerche sui meccanismi monocellulari della memoria, nel tentativo di attribuire al pensiero psichiatrico e alla formazione dei futuri psichiatri un ruolo sempre più centrale nel contesto della biologia moderna, delinea un nuovo quadro intellettuale che deriva dal pensiero biologico riguardante la relazione tra mente e cervello. Lo scopo di questa nuova cornice è duplice: sottolineare come i requisiti professionali dei futuri psichiatri richiederanno una sempre maggiore conoscenza della struttura e del funzionamento del cervello rispetto a quanto avviene ancora oggi; illustrare come l’analisi dell’interazione tra i determinanti sociali e biologici del comportamento debba essere studiata in modo più approfondito, tramite una piena comprensione dei componenti biologici legati al comportamento.
Si possono fare alcuni esempi di come includere i dati neurobiologici nell’ascolto del paziente sia indispensabile. Ci sono evidenze scientifiche delle capacità di risposta infiammatoria del cervello – che erano ignote fino a vent’anni fa –, che precedono e avviano i cambiamenti della sua plasticità normale, facendolo poi disfunzionare; solo a questo punto emergono sintomi e comportamenti psicopatologici: trascurare oggi queste risposte significa non comprendere i primi segnali soggettivi di molta psicopatologia. Ci sono anche evidenze del fatto che l’attività di immunoregolatore svolta dal cervello venga “vissuta” senza consapevolezza, come attraverso “settimo senso” (Kipnis, 2018), quindi rientrando in quelle esperienze inconsce che non sono rappresentate nella narrazione mentale, ma in un inconscio “non mentale”, quello della memoria immunologica.
Come fare per utilizzare tutta questa messe di informazioni? Come impiegare le informazioni che il paziente ci riferisce, quelle che cogliamo nell’incontro senza che siano espresse verbalmente e anche quelle che i dati strumentali o di laboratorio ci mettono a disposizione, e che oggi danno significato a quanto viene comunicato?
Alcuni suggeriscono che ci si debba far aiutare dalle nuove tecnologie, come per esempio l’apprendimento automatico. Conosciuto anche con l’espressione anglosassone “machine learning”, è una branca dell’intelligenza artificiale, all’interno della quale vengono convogliati tutti i metodi sviluppati negli ultimi decenni del XX secolo (statistica computazionale, reti neurali artificiali, sistemi dinamici di elaborazione delle informazioni e algoritmi adattivi). Altri vanno oltre, arrivando a proporre l’utilizzo di surrogati tecnologici simili ad Alexa, l’assistente vocale sviluppato da Amazon, o ai chatbot, nei quali già adesso ci imbattiamo facendo acquisti online. Si tratterebbe di utilizzare software progettati per simulare una conversazione, in questo caso con un health provider. Ma si tratta di proposte che non possono essere prese in considerazione, perché l’incontro con il paziente è un dialogo: è un reciproco interrogarsi. Anzi di più, è un particolare modo di interrogarsi: non ci si può limitare a fare domande, perché altrimenti, come ricordava Balint (1990), si avranno “solo riposte”; occorre invece dare voce anche alle pause e a silenzi. Il paziente cerca un soggetto che lo capisca, e così gli consenta di riconoscersi come persona, ma anche gli infonda e trasferisca elementi che gli permettano di affrontare meglio il difficile passaggio della malattia. È quello che viene chiamato empowerment, ovvero accordare più potere al paziente nel processo di cura, attraverso la sua valorizzazione personale e anche attribuendogli un ruolo nella gestione delle informazioni.
Nell’incontro con il terapeuta è il paziente che deve sapere qualcosa di più riguardo a sé stesso e anche riguardo alla sua condizione di disagio. Questa unicità del colloquio ci fa ritornare a un concetto di pratica artigianale, dove il terapeuta torni ad essere un “artigiano”: un artigiano che conosca le tecniche di ascolto, ma anche la materia in cui il racconto si fa memoria, in un ascolto oggi più complesso e ancora più importante.
Stefano Pallanti, professore di Psichiatria presso l’Albert Einstein College of Medicine e il Centro Medico Montefiore, New York, è docente anche alla scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Pisa e direttore dell’Istituto di Neuroscienze di Firenze.
Bibliografia
Andreasen N. C. (2007), «DSM and the death of phenomenology in America: An example of unintended consequences», Schizophrenia Bulletin, 33 (1), 108-112.
Balint M. (1990), Medico, paziente e malattia (trad. it.), Feltrinelli, Milano.
Bleurer E. (1967), Trattato di psichiatria (trad. it.), Feltrinelli, Milano.
Dashorst P., Mooren T. M., Kleber R. J., de Jong P. J., Huntjens R. J. C. (2019), «Intergenerational consequences of the holocaust on offspring mental health: A systematic review of associated factors and mechanisms», European Journal of Psychotraumatology, 10 (1), 1654065.
Https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento automatico se Amazon si mette a fare il medico: Il giornale della previdenza dei medici ed odontoiatri Anno XXVI n$ \2021
Insel T., Cuthbert B., Garvey M., Heinssen R., Pine D. S., Quinn K., Sanislow C., Wang P. (2010), «Research domain criteria (RDoC): Toward a new classification framework for research on mental disorders», American Journal of Psychiatry, 167 (7), 748-751.
Kandel E. R. (1998), «A new intellectual framework for psychiatry», The American Journal of Psychiatry, 155 (4), 457-469.
Kipnis J. (2018), «Immune system: “The seventh sense”», The Journal of Experimental Medicine, 215 (2), 397-398.
Kupfer D. J., First M. B., Regier D. A. (Eds., 2002), A research agenda for DSM - V. American Psychiatric Association.
Laing R. (1967), La politica dell’esperienza – L’uccello del paradiso (trad. it.), Feltrinelli, Milano.
Orange D. M., Atwood G. E., Stolorow R. D. (2001), Working intersubjectively: Contextualism in psychoanalytic practice, Routledge, New York.
Pallanti S. (1994), «Fenomenologia e neuroscienze». In Trattato italiano di psichiatria, vol. 3: Psicologia e neuroscienze, Edra Masson, Milano.
Pallanti S. (2020), Psichiatria e salute comportamentale: diagnosi e terapie, Carocci, Roma.
Sennett R. (2008), L’uomo artigiano (trad. it.), Feltrinelli, Milano.
Seung S. (2012), Connectome: How the brain’s wiring makes us who we are, Houghton Mifflin Harcourt, Boston.
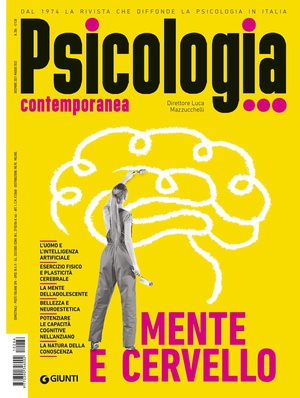
Questo articolo è di ed è presente nel numero 286 della rivista. Consulta la pagina dedicata alla rivista per trovare gli altri articoli presenti in questo numero. Clicca qui


