La scienza che fa notizia. Usi e abusi della comunicazione dei risultati delle neuroscienze
Comunicare con efficacia comporta spesso di banalizzare o generalizzare verità scientifiche strumentalizzandole a fini di controllo sociale e culturale. Niente di più pericoloso.
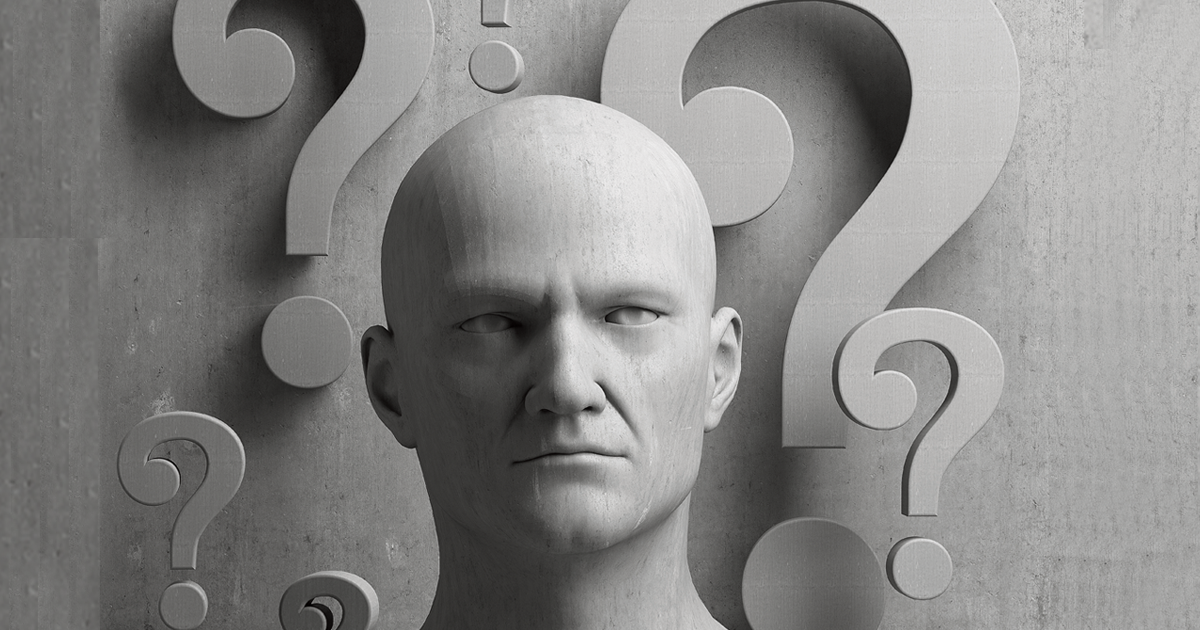
I mezzi di comunicazione e il web riportano spesso “notizie scientifiche” che riprendono i risultati di ricerche sperimentali per diffonderli al grande pubblico. Il formato di queste comunicazioni è vario: si va dai pochi minuti di un servizio al telegiornale ai programmi di divulgazione scientifica; dalle riviste specializzate agli instant-book; dalle mostre e i musei scientifici agli articoli su Wikipedia e ai post su YouTube, diversi per lunghezza e scopo di approfondimento.
Ciò che accomuna molte di queste divulgazioni è presentare la scienza come una sorta di magia, e l’esperto diventa un illusionista pronto a presentare le domande e le risposte del percorso scientifico, senza poter esplicitarne i necessari e complessi passaggi. Come Conan Doyle faceva dire a Sherlock Holmes, «Non è difficile costruire una serie di deduzioni, una dipendente dall’altra e ciascuna semplice in sé. Se dopo questo processo si eliminano le deduzioni centrali e si offrono al pubblico semplicemente l’inizio e la conclusione, si ottiene un effetto sorprendente anche se un po’ teatrale».
DIVULGARE LA SCIENZA: PIÙ DIFFICILE CHE PRODURLA?
Seguendo tale procedura semplificatoria, la scienza sembra poter proclamare certezze inattaccabili. Ecologia, cellule staminali, clonazione, differenze sessuali, alimentazione, psicopatologie, criminalità, uso di farmaci o sostanze psicoattive… la ricerca (o almeno, lo scienziato di turno che la rappresenta) sembra avere una soluzione chiara e distinta per tutti i problemi, anche quelli più controversi. Ma la scienza è quella che viene sintetizzata negli articoli dei giornali o nelle interviste televisive o nei post su Internet?
A fronte di un’opinione pubblica che chiede supporto alla scienza su problemi che non sa – o non può – approfondire, gli scienziati e i divulgatori di scienza spesso non riescono a comunicare adeguatamente con la società (Gregory e Miller, 1998; Borgna, 2001; Bencivelli e de Ceglia, 2013).
Vediamo qualche esempio, limitato alla stampa. Anni fa, mentre gli psicologi approfondivano la concezione “incrementale” dell’intelligenza (che si può potenziare con opportune stimolazioni), uno dei più diffusi quotidiani italiani confermava al grande pubblico l’idea di un’origine genetica dell’intelligenza e della stupidità, in un articolo con l’intrigante titolo «Scoperto il gene che rende stupidi». Il sottotitolo proclamava: «Abbiamo trovato la chiave che spiega come si forma e come funziona quel gioiello dell’evoluzione che è la corteccia cerebrale. Lì ci sono l’intelligenza, il suo contrario, e, secondo alcuni, anche l’anima». Tralasciamo quest’ultimo riferimento spirituale, che l’articolista ha inserito senza che c’entrasse nulla col resto. Il concetto che si trasmette, attribuendone la paternità alla scienza, è che l’intelligenza è determinata geneticamente. Se ne deduce che, se essa è limitata alla nascita, qualunque sforzo per promuoverla sarebbe inutile. Insomma, la conferma del proverbio popolare «Chi nasce rotondo non muore quadrato». Conclusione che trascura il ruolo dell’epigenetica e quindi della stimolazione ambientale, oggi ampiamente riconosciuto dai genetisti stessi.
In realtà, lo studio scientifico da cui la divulgazione prendeva spunto aveva individuato uno specifico gene che determinò la mutazione di alcuni pesci verso forme più evolute, da cui ebbero origine le scimmie e poi gli umani: un gene, dunque, che aveva promosso l’intelligenza nell’evoluzione delle specie, e non la stupidità nelle singole persone, come il titolo fuorviante lasciava credere.
Un altro articolo giornalistico presentava così una sensazionale scoperta: «Passo in avanti decisivo per trasformare in realtà la vita artificiale: è stato costruito in laboratorio il primo cromosoma sintetico di un organismo complesso. Il risultato, pubblicato su Science, è cruciale per progettare organismi “su misura” per compiti specifici, come produrre farmaci o biocarburanti. Per la prima volta, nel campo della vita artificiale, si passa da un regno a un altro: da quello degli organismi più semplici, come i batteri, a quello degli eucarioti, le cui cellule hanno un nucleo come quelle dell’uomo».
A ben vedere, il cromosoma sintetico di cui si parlava sostituiva uno di quelli presenti nel lievito comunemente usato per fare il pane. La suggestione che dal lievito si possa passare agli insetti, poi ai farmaci, poi a chissà cos’altro, finisce per turbare il lettore che si ricollega alla clonazione e alla pecora Dolly, e poco si fida delle capacità di autolimitazione della bioingegneria e della forza di controllo della bioetica.
“VERITÀ” AD EFFETTO
Ancora un titolo ad effetto di un articolo sulla pagina della cultura di un diffuso quotidiano: «Predestinati alla bontà, dai nostri geni». Per avallare la tesi che «esiste un codice morale universale con precise basi neurologiche», un professore di psicologia di Harvard spiegava che «il senso morale non deriva dalla religione che ci viene inculcata; i principi morali che ciascuno sente di rispettare sono pre-programmati nel nostro cervello fin dalla nascita e hanno basi neurobiologiche».
In verità, nessuno scienziato serio penserebbe che la religione è l’unica fonte del senso morale, né un genetista sosterrebbe che i principi morali stanno già nella programmazione genetica. Sappiamo che tutto può essere iscritto nei geni o nei circuiti neuronali, ma – tranne il caso di rilevanti alterazioni genetiche che condizionano direttamente il comportamento – sono lo sviluppo sociale e l’educazione a influenzare il modo in cui le potenzialità biologiche si traducono in abitudini comportamentali e tratti di personalità. Diventa fuorviante presentare all’opinione pubblica, con l’autorevolezza del supporto della ricerca scientifica, l’idea che sono la biologia e la genetica a decidere chi sarà buono e chi cattivo, sottovalutando il contributo che l’educazione e i valori culturali possono dare in un senso che proprio la neuroscienza definisce “epigenetico”. Quando si riportano solo le conclusioni degli studi scientifici, saltando tutta la complessità delle variabili e dei ragionamenti intermedi e dimenticando la necessaria prudenza sulle inferenze che se ne possono trarre, si trascurano alcune essenziali cautele metodologiche che gli scienziati conoscono bene: l’impossibilità di dedurre direzioni causali dalle correlazioni lineari, per cui alcuni fenomeni coesistono, ma non perché uno di essi causi l’altro; il rischio che l’incidenza di variabili sovraordinate non considerate possa contribuire a scoprire relazioni illusorie tra le variabili osservate; la necessità di molti studi convergenti sugli stessi risultati per confermare o disconfermare le conclusioni, che sarebbe azzardato generalizzare a partire da un unico studio con specifiche caratteristiche di campionamento, strumenti, analisi dei dati, variabili di contesto ecc.
Certo, la complessità di alcuni temi e la molteplicità di procedure per studiarli possono confondere e sono poco adatte alla divulgazione. E allora semplificare nei pochi minuti di un’intervista, o nelle limitate righe di un post, diventa la scorciatoia facile e gradita sia a chi scrive che a chi legge. A proposito del lettore, Jung diceva che è influenzato «dal pregiudizio positivista che pretende che la verità è semplice e può essere espressa da una frase sintetica». Oggi si direbbe: espressa dal titolo e il sottotitolo dell’articolo giornalistico o sul web, oltre cui il lettore comune spesso si inoltra poco. E il giornalista si adegua a una comunicazione chiara nella sua sinteticità, ma riduzionista rispetto alla complessità dell’argomento.
I veri scienziati sanno bene che le conclusioni cui sono arrivati non sono mai assolute e definitive, ma dipendono dalle teorie di riferimento, dalle ipotesi di partenza, dalle modalità scelte per la verifica, dal modo di analizzare e interpretare i dati. Sanno pure che, partendo da presupposti e da ipotesi differenti, scegliendo altri metodi, analizzando e interpretando diversamente i dati, si può arrivare a conclusioni divergenti che potrebbero essere ugualmente legittime, portando però a deduzioni applicative diverse.
Ben diverso da questo dubbio insito nella complessità della scienza è il panorama delle semplificazioni riportate sui media. È sconfortante leggere e sentire scienziati diversi parlare di cause ed effetti dell’attuale pandemia, di prevenzione e di terapia, di vaccini. Ognuno afferma la propria verità, alla quale subito un altro contrappone una verità diversa, ottenuta basandosi su presupposti e metodi diversi. Ma non è una novità: in passato tanti scienziati si sono slanciati (lasciando che i media riprendessero questi slanci) in drastiche affermazioni basate su dati che a loro sembravano incontrovertibili, mentre poi sono stati clamorosamente smentiti da nuovi dati diversi.
Alcuni esempi eclatanti del passato: il famoso fisico lord Kelvin, presidente della prestigiosa Royal Society inglese, nel 1895 irrideva la possibilità di sollevare in volo macchine più pesanti dell’aria; e nel 1960 il premio Nobel Frank Burnet sosteneva che la biologia molecolare non aveva ricadute pratiche, e quindi non poteva essere di alcun aiuto all’umanità!
Questo, per limitarsi alle previsioni azzardate ma in buona fede, senza parlare delle “bufale” frutto di errori metodologici o addirittura di inganno, che costituiscono un capitolo a parte della produzione e comunicazione della scienza. Ci vuole tanta prudenza da parte degli scienziati nell’avanzare predizioni in base ai propri risultati, e altrettanta ce ne vuole da parte di chi presenta questi risultati ai decisori politici e all’opinione pubblica.
COMUNICARE LA NEUROSCIENZA
La neuroscienza, più di altre discipline, corre i rischi di semplificazione nella comunicazione dei suoi risultati, perché riguarda ambiti per natura complessi legati alla mente umana, alle sue origini e alla sua evoluzione, alle relazioni sociali e ai contenuti economici, etici, valoriali che esse comportano.
Il paragrafo qui sotto parla di un articolo divulgativo sulle nuove affascinanti frontiere delle ricerche neuroscientifiche, in cui è evidente una semplificazione che sa quasi di propaganda. Pensiamo in particolare all’intelligenza artificiale, e alla robotica, che ne è la applicazione più potente e affascinante. Nell’opinione pubblica si è passati dalla acritica paura che gli agenti artificiali possano sopraffare l’umanità (sostenuta da tanti romanzi e film di successo) alla altrettanto indiscriminata fiducia nella loro capacità di supportare tutti gli ambiti della vita umana: dal navigatore satellitare che ci fa da guida in auto all’assistente vocale che risponde paziente alle nostre domande; dalla domotica alla realtà virtuale; dai robot industriali a quelli che assistono le persone con disabilità; fino agli androidi, che qualcuno propone di utilizzare per simulare la vita presente e anche futura, promettendo che un nostro avatar potrà avere una vita eterna in un cloud (Di Nuovo, 2018). Il modo in cui queste scoperte vengono presentate, sui media e su YouTube, dimentica che ci sono aspetti della intelligenza artificiale che possono complicarne o pregiudicarne l’uso effettivo:
l’usabilità: cioè la possibilità che certe categorie di utenti (pensiamo agli anziani o alle persone con disabilità) se ne avvalgano agevolmente;
l’accettabilità: la disponibilità dei potenziali utenti nell’affidarsi alle tecnologie intelligenti, non scontata in certe categorie come quelle degli operatori di assistenza o dei terapeuti;
i costi ancora troppo elevati per essere sostenibili su larga scala dalle comunità sociali;
i risvolti etici non indifferenti, relativi al controllo di questi agenti artificiali e delle loro finalità, che ha indotto la Commissione Europea (2019) a formulare un codice etico per una intelligenza artificiale sostenibile.
Trascurando questi problemi, si rappresenta indebitamente l’intelligenza artificiale, frontiera avanzata della neuroscienza, come una panacea per risolvere i problemi del mondo.
CANCELLARE DAL CERVELLO LE MEMORIE DOLOROSE. MA È PROPRIO COSÌ?
Qualche tempo fa sulla stampa e sui social è stata diffusa una notizia proveniente dai laboratori della John Hopkins University. Si è detto che era stata identificata una proteina che agisce come una gomma da cancellare sull’area cerebrale che registra nella memoria i ricordi paurosi. L’esperimento è stato condotto sui topi, spaventando gli animali con un forte rumore, e successivamente verificando che nel gruppo di topi in cui era stata eliminata dal cervello la “proteina-gomma”, il rumore non veniva più collegato alla paura. A differenza degli animali del gruppo di controllo, i topi biologicamente modificati sembravano aver dimenticato la paura indotta dal rumore. Secondo i ricercatori, sono stati indeboliti i collegamenti che si creano nel cervello fra un evento e un trauma, cancellandone la stessa memoria. Questa che può sembrare fantascienza, e che richiama il famoso film Se mi lasci ti cancello, viene presentata sui media come una modalità concreta per il trattamento mediante farmaci delle sindromi da stress post-traumatico conseguenti alla guerra, a stupri o altri eventi dolorosi. Il grande pubblico è indotto a pensare che con questa scoperta delle neuroscienze si apre la possibilità di manipolare i ricordi, e dimenticare quelli spiacevoli.
Ma questa semplificazione è corretta? È tecnicamente (ed eticamente) utile usare un farmaco come un “cancellino” per i ricordi spiacevoli, compreso il trauma di uno stupro? Oppure si enfatizza la generalizzazione di esperimenti su questioni limitate (e peraltro basati su animali) al futuro del genere umano?
GLI USI IMPROPRI DELLA SCIENZA
La scienza viene spesso comunicata in modo sommario, riducendo la complessità dei problemi e presentando solo piccoli tasselli del puzzle totale, svincolati dal contesto e dalle cautele e i dubbi con cui tutti gli scienziati seri accompagnano le loro scoperte. Si apre così la strada a un uso acritico, e quindi stereotipico e pregiudiziale, dei suoi risultati. La scienza diventa agente di pregiudizio quando pretende – o le viene assegnato il compito – di avere l’ultima parola su questioni sociali che vanno oltre i propri confini ed esigono decisioni di tipo diverso, etico o politico.
Come ha scritto Frank Furedi (2007), e come si può constatare durante gli eventi critici, la scienza viene usata dalla politica per fondare sui risultati delle ricerche (che seguono una logica “probabilmente vero/probabilmente falso” e che non arrivano mai a certezze definitive) decisioni che invece vanno prese in termini di “giusto-sbagliato”, o di “utile-dannoso”. Essa diventa così un alibi per far da copertura a decisioni che riguardano la morale o la politica, e che in questi termini sarebbero più difficili da far accettare all’opinione pubblica. Pensiamo a certe norme in ambito giudiziario, o ecologico, o sull’assunzione di alimenti o di sostanze (o, di recente, di vaccini), che sono promulgate sulla base di dati “scientifici”: dati che, pur non essendo né completi né definitivi, colpiscono e turbano una parte della popolazione e gli stessi legislatori che la rappresentano.
La scienza non può e non deve dare coperture legittimanti a provvedimenti di altra natura. Di questi, semmai, può porre le premesse presentando i dati, insieme ai loro limiti, a chi deve assumersi la responsabilità decisionale, e che dei dubbi e delle possibili alternative deve tenere conto nel decidere. E lo scienziato – il neuroscienziato in particolare – deve ritenersi direttamente responsabile della divulgazione e dell’uso delle sue idee, senza lasciarle a un addetto stampa, al divulgatore scientifico di professione (magari portatore di precisi interessi), al giornalista in cerca di scoop o al web in cerca di follower. O, peggio, al politico in cerca di consenso.
Le semplificazioni con titoli ad effetto non servono né al pubblico né alla scienza stessa. Fare buona scienza non è facile – divulgarla bene lo è ancora meno.
Santo Di Nuovo, docente di Psicologia cognitiva e neuroscienze e di Psicologia giuridica nell’Università di Catania, è presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia. Tra le sue numerose pubblicazioni, ricordiamo Prigionieri delle neuroscienze? (Giunti, 2014).
Bibliografia
Bencivelli S., de Ceglia F. P. (2013), Comunicare la scienza, Carocci, Roma.
Borgna P. (2001), Immagini pubbliche della scienza, Edizioni di Comunità, Roma.
Cangelosi A., Di Nuovo S. (2017), Simulare la mente. Intelligenza artificiale e robot nella vita quotidiana, Giunti, Firenze.
Di Nuovo S. (2018), «Un futuro eterno nel cloud? La proposta dell’avatar immortale», Psicologia contemporanea, 267, 40-45.
European Commission’s high-level expert group on artificial intelligence (2019), «Draft Ethics guidelines for trustworthy AI.», E.C., Bruxelles.
Furedi F. (2007), Che fine hanno fatto gli intellettuali? I filistei del XX secolo (trad. it.), Raffaello Cortina Editore, Milano.
Gregory J., Miller S. (1998), Science in public: Communication, culture and credibility, Basic Books, New York.

Questo articolo è di ed è presente nel numero 285 della rivista. Consulta la pagina dedicata alla rivista per trovare gli altri articoli presenti in questo numero. Clicca qui


