Qualche volta contrarre una dipendenza costituisce un tentativo di via d’uscita da un’impasse. Salvo restare incastrati in quella che doveva essere la soluzione.

La gente pensa che si tratti di miseria, disperazione, morte. Ma, quello che la gente dimentica è quanto sia piacevole, sennò noi non lo faremmo. In fondo, non siamo mica stupidi! Almeno non fino a questo punto». Così afferma Mark Renton, detto Rent, sulla tossicodipendenza, nel film Trainspotting di Danny Boyle, del 1996. Si tratta di un’asserzione spiazzante, scomoda, con la quale conviene però fare i conti. Già, perché l’uomo, come ogni altro mammifero presente sul pianeta, è una crea-tura conservativa, con un’identità precisa edificata attorno all’istinto di sopravvivenza. Cosa può spingere, quindi, un essere umano verso una condotta certificata come autodistruttiva, annientante, letale? (CONTINUA...)
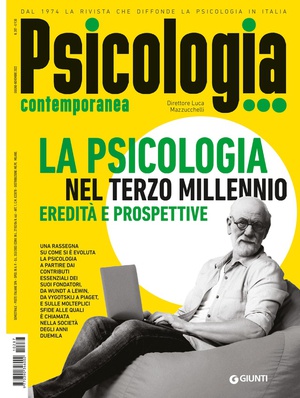
La risposta di Rent è semplice e diretta: lo sballo. La droga, insomma, piace da morire. Tuttavia, non tutte le sostanze garantiscono viaggi euforici e sensazioni di onnipotenza. Molte forme di dipendenza, al contrario, appaiono associate ad aspetti disforici, di tristezza e angoscia. Recenti contributi sottolineano l’importanza delle attribuzioni di significato nel costruire, e mantenere, le dipendenze (Pensa, 2018): ogni individuo crea la propria dipendenza sulla base del proprio modo di essere, delle proprie debolezze e aspirazioni. Gregory Bateson (1972) sosteneva che l’alcolismo è il tentativo del soggetto di sfuggire a una premessa culturale soffocante, quella che impone di essere “capitani della propria anima”, sempre sotto controllo, sempre in comando e, in ultima analisi, soli con sé stessi. Benché sia impossibile ricondurre ogni forma di tossicomania a questo aspetto, è pur sempre interessante come la premessa di Bateson ribalti la questione della dipendenza: da problema a, sia pure goffa e terribilmente pericolosa, soluzione. Ma rispetto a quale problema?
Marco e Marzia: svincolo o differenziazione?
Una prima risposta ce la offre la vicenda di Marco, giornalista musicale di 33 anni, molte idee in testa e pochi soldi in tasca. A contattarmi è la moglie Marzia, maestra elementare, sua coetanea.
Come accade molto spesso, la telefonata di Marzia è un lungo elenco di problemi del marito, dalla bassa autostima a uno scarso autocontrollo, fino a giungere a quella che sembra la vera preoccupazione: l’uso di cocaina, sia pure – nelle parole della donna – «occasionale».
Marzia si dice preoccupata soprattutto per il fatto che, da qualche mese, lei e Marco stanno parlando dell’idea di avere un figlio, «e non mi sentirei sicura a dare alla luce un bambino in una casa dove gira della droga».
Quando incontro la coppia per un primo colloquio, mi colpiscono l’intesa affettuosa, la dolcezza di Marco, la comprensione di Marzia: considerate le premesse, non mi sarei certo aspettato un tale idillio! I due raccontano con dovizia di particolari la lotta per stare assieme contro il volere delle famiglie.
La madre di Marzia, Anita, è descritta come una donna inflessibile, convinta che qualsiasi legame tra uomo e donna condanni quest’ultima all’infelicità e alla schiavitù. Anita si è opposta con ogni mezzo all’unione tra i due, fino al punto di non presenziare al matrimonio. Le visite di Anita alla figlia sono estenuanti interrogatori, al termine dei quali lo sguardo deluso e critico della donna risuona in Marzia come una sentenza di colpevolezza: «È come se m’incolpasse di averla lasciata, anche se per una vita mi ha detto che una donna dev’essere autonoma!».
Marco, al contrario, ha genitori «accudenti, accomodanti e protettivi», in particolare la madre Antonia. La preoccupazione di Antonia, semmai, è che nessuna donna potrà mai amare e prendersi cura di Marco come lei. Al matrimonio, riferisce Marco non senza imbarazzo, è scoppiata in un pianto inconsolabile, obbligando suo marito ad accompagnarla fuori durante la celebrazione.
Su un unico punto Antonia e Anita, pur così diverse, sembrano concordi: se i due sposini avessero un figlio, sarebbe una catastrofe! Antonia considera Marco troppo giovane e immaturo per la paternità. Sarebbe per lui una fonte di stress e preoccupazione. Crede inoltre che un figlio lo obbligherebbe a rinunciare al sogno della carriera giornalistica, in favore di un impiego più concreto ma soffocante, ed è terrorizzata all’idea di vederlo infelice. Anita è convinta che un figlio sarebbe il sigillo sulle catene di Marzia, condannata a quel punto a una vita di pannolini e biberon, senza più alcuna libertà: «Non devi fare la mia fine!».
La vicenda di Marco e Marzia rivela la centralità di una questione spesso dibattuta quando si parla di adolescenti, ma non sempre tenuta in debita considerazione rispetto al mondo adulto, ossia quella che Murray Bowen (1977) chiama «differenziazione»: la capacità di un soggetto di evolvere, sviluppando la propria personalità e le inclinazioni individuali, pur mantenendo un legame armonioso con la famiglia di origine. Secondo Bowen, è auspicabile che tale processo si realizzi come equilibrio dinamico tra emancipazione del soggetto e mantenimento degli affetti.
Questo equilibrio tra appartenenza al sistema e capacità di stabilire confini individuali che differenzino il singolo dal gruppo è da ritenersi un compito cruciale non soltanto del soggetto, ma dell’intera famiglia, come sottolineato da Maurizio Andolfi (2003): «L’obiettivo più importante per la famiglia è quello di aiutare i propri membri a migliorare il livello di differenziazione del Sé, nel raggiungimento del complesso equilibrio tra appartenenza e separazione».
Come riconoscere, tuttavia, quando tale obiettivo è raggiunto? Purtroppo, con il tempo, il concetto di differenziazione ha subito un’implicita trasformazione tanto nel senso comune quanto nella pratica clinica, al punto che la questione della capacità di maturare caratteristiche uniche rispetto al gruppo, pur restandovi inclusi, viene spesso ridotta a una mera faccenda di luoghi, finendo per far collassare lo stesso concetto di differenziazione in quello, più angusto e bidimensionale, di svincolo: in sintesi, è vincolato chi ancora vive con la famiglia d’origine, mentre l’uscita dalla casa natia rappresenta il segno inequivocabile e tangibile del sospirato svincolo.
Se torniamo alla vicenda di Marco e Marzia, le cose, peraltro, si rivelano assai più complesse: entrambi appaiono infatti svincolati, ma sono differenziati? Hanno cioè realizzato quel processo di costruzione di un’identità propria e distinta, pur mantenendo una positiva connessione con le famiglie di origine? La costituzione di un proprio nido di coppia, ufficializzato e reso visibile a tutti attraverso il matrimonio, costituisce un’importante spinta separativa, tuttavia occorre interrogarsi sulla qualità di tale separazione.
Nelle parole di Stierlin (1973; 1979) ci si imbatte sovente in due tipi di svincolo: uno di natura centrifuga e uno di natura centripeta. Lo svincolo centrifugo è caratterizzato da una forte incitazione, da parte dei genitori, all’autonomia dei figli e, al tempo stesso, da una massiccia ambivalenza: il figlio è spinto con ogni mezzo sulla soglia di casa, ma nell’istante in cui dovesse varcarla, verrebbe implicitamente biasimato per aver tradito e abbandonato la famiglia. Nello svincolo centripeto, al contrario, i genitori lamentano spesso l’immaturità e mancanza di autonomia del figlio, ma al contempo mettono in atto comportamenti che hanno l’effetto di infantilizzarlo rendendolo, a tutti gli effetti, sempre più dipendente.
In entrambi i casi, secondo Stierlin, non si assisterebbe a una differenziazione completa, poiché spesso lo svincolo dal nucleo originario comporterebbe un’illusione di autonomia, più che una differenziazione reale. Marzia e Marco sembrano rappresentare due casi quasi prototipici di queste due modalità: Anita ha sempre preteso dalla figlia Marzia che si rendesse autonoma, ma non le perdona di averla abbandonata per Marco; Antonia alza spesso gli occhi al cielo di fronte alla palese immaturità del figlio, ma fa di tutto per mantenerlo un eterno ragazzo, pieno di sogni e bisogni, purché senza concretezza.
La cocaina entra in questo gioco familiare come la più paradossale delle soluzioni, scongiurando a tutti gli effetti l’eventualità più temuta da entrambe le famiglie, appunto la procreazione di un figlio: essa è infatti intransitiva con il progetto genitoriale. In tal modo permette ai due coniugi di mantenersi in questo stato di svincolo dalla famiglia senza però ultimare il processo di differenziazione. Marzia si ritrova ad avere un’autonomia dimezzata, poiché la sfiducia che prova nei confronti di Marco, che pure ama, la avvicina suo malgrado alla propria madre, sedando così la rabbia di quest’ultima per l’abbandono. Marco, dal canto suo, ha fatto un passo emancipativo con il matrimonio. Tuttavia la sua inaffidabilità, dovuta alla sostanza assunta e alla conseguente non concretizzazione dei progetti di vita adulta (egli vorrebbe iscriversi a un master per critici musicali, ma la cocaina dimezza costantemente il suo budget), mantiene inalterata, agli occhi della madre, l’immagine di eterno ragazzo del quale prendersi cura.
Sarà soltanto la presa in carico, da parte della coppia, dei conflitti e dei dilemmi irrisolti, legati alla mancata individuazione e differenziazione, a rendere possibili un percorso maturativo di Marco e il suo progressivo distanziarsi dalla cocaina. Per Marco e Marzia, una dipendenza, sia pure blanda – quella dalla cocaina –, può talvolta coprirne un’altra, ben più profonda e radicata: quella dalla famiglia d’origine.
Giuliano, l’insospettabile
Una delle assunzioni più frequenti nel senso comune è che esistano sostanze da “poveri”, più comuni nelle fasce disagiate della popolazione, e sostanze da “ricchi”. Se la cocaina è spesso considerata una droga da quartieri alti, non altrettanto si può dire del vino, soprattutto a causa della facilità con cui le persone dipendenti da esso possono reperirne dosi a un costo relativamente basso. Proprio per questo motivo il caso di Giulio, manager cinquantenne all’apice della carriera, si pone come un’eccezione interessante.
Anche in questo caso, come spesso accade in situazioni di soggetti dipendenti, il primo contatto non è stabilito dal diretto interessato, ma dalla sorella Stefania, di dieci anni più grande. A colpirmi, nel modo in cui la donna parla del fratello, è il tono costantemente in bilico tra aperta ammirazione («Giuliano è un uomo bellissimo… ha un’intelligenza straordinaria… qualunque donna vorrebbe al fianco un uomo come lui») e un’esplicita squalifica («È incapace di prendere in mano la sua vita… si tratta di un eterno infelice… non ha autocontrollo, come i bambini»). Solo dopo una lunga introduzione sulla complessa e sfaccettata personalità del fratello minore, Stefania si decide a dirmi qual è il problema per il quale mi ha contattato: la dipendenza di Giuliano dal vino, che si traduce in frequenti «sbornie» nel corso delle quali diviene cattivo e violento (solo verso gli oggetti, «almeno per ora», specifica la donna). A farne le spese è soprattutto la compagna di lui, Aurora, talmente spaventata da quegli sfoghi da telefonarle nel cuore della notte chiedendole di intervenire.
Ancora una volta, resto colpito dalla “doppia descrizione” che Stefania fa di Aurora: ora confidente e complice («È stata lei a darmi le chiavi di casa loro, così che possa far sparire le bottiglie quando essi sono assenti»), ora causa di ogni problema («È lei a renderlo infelice… non avrebbe dovuto scegliere una donna con un carattere così volubile»).
Giuliano appare come un uomo ben svincolato: un lavoro elettrizzante e ottimamente remunerato, e una compagna invidiata da tutti per fascino e intelligenza. Tuttavia, la dipendenza dall’alcol trasforma quel quadro idilliaco in uno scenario di disperazione suburbana, con mobili fracassati, urla, interventi della polizia. In quel contesto, suona come un interessante campanello di allarme che una questione di tale importanza sia delegata in prima battuta alla sorella di lui.
È Giuliano a parlare in prima persona del rapporto con Stefania durante il nostro primo incontro: cresciuti assieme e obbligati a badare l’una all’altro dopo la precoce morte di entrambi i genitori, Giuliano e Stefania hanno fatto coppia fissa per anni e in ogni circostanza. Spesso, racconta Giuliano con un sogghigno divertito, le persone, incontrandoli, li scambiavano per fidanzati, «Ma lei è invecchiata prima e peggio di me, e ora non capita più». L’amore che Stefania prova per Giuliano non si è mai esteso alle sue fidanzate, alle quali ha sempre fatto una guerra spietata, da cui è sempre uscita vincitrice, fino all’avvento di Aurora, tre anni addietro. Fino ad allora, Giuliano non era mai stato tipo da grandi innamoramenti: «Amavo godermi la vita e le belle donne, ma ho sempre avuto chiaro in mente che il lavoro veniva prima di ogni altra cosa».
L’incontro con Aurora, per quello scapolo impenitente e in ascesa, è un vero e proprio colpo di fulmine. Quello che a prima vista appare come il movimento che chiude il cerchio del processo di differenziazione di Giuliano, cioè l’innamoramento e l’inizio della convivenza con Aurora, si rivela ben presto un dilemma insolubile. La donna, infatti, non è disposta in alcun modo ad accettare le ingerenze di Stefania nella vita di coppia, ponendo fin da subito paletti assai restrittivi circa la sua presenza. Stefania, consapevole dell’importanza inedita di quel rapporto, non si azzarda a fare un’opposizione aperta, ma il suo dolore e la sua tristezza per l’allontanamento del fratello sono evidenti.
I tentativi di Giuliano di far andare d’accordo le due donne si rivelano fallimentari, e risulta evidente che per lui scegliere tra la donna di cui è innamorato e colei che si è presa cura di lui sin da bambini è un compito impossibile. È interessante osservare come, anche in questa occasione, ci troviamo di fronte a un uomo all’apparenza emancipato e realizzato: mai ci aspetteremmo, quindi, di scoprire in lui i segni di una mancata differenziazione. Nel suo caso, infatti, non sono l’autonomia e l’indipendenza ad essere problematiche, come nel precedente caso di Marco, bensì l’amore per una donna diversa dalla sorella Stefania.
Ancora una volta la dipendenza, mentre configura un ovvio problema sul piano individuale, si pone come una soluzione creativa e quasi “geniale” al problema della famiglia: infatti, è proprio il vino a “consegnare” le chiavi di casa a Stefania, obbligando le due donne a cooperare per il bene di colui che entrambe amano.
Affrontare il tema di come ricomporre le proprie leal-tà familiari, bilanciando la propria appartenenza a Stefania con lo sviluppo del proprio progetto esistenziale (contemplante il mantenimento e consolidamento della relazione con Aurora), diventa per Giuliano l’unica reale possibilità di affrancamento dalla dipendenza.
Conclusioni
Lo svincolo dalla famiglia non è, di per sé, un’operazione semplice. Come dimenticare l’immortale «bamboccioni» pronunciato una decina di anni fa dall’allora ministro Padoa-Schioppa, fotografia di un’effettiva difficoltà, spesso anche di carattere finanziario, ad abbandonare il nucleo familiare di origine? Tuttavia, benché si tratti di un passo importante e non sempre facilissimo, lo svincolo fisico dal nucleo di origine non risolve in via definitiva il processo di differenziazione. In esso, infatti, risiedono dimensioni emotive, affettive e relazionali che non possono essere ridotte, come nel caso di Marco e Marzia, a una mera questione di distanza fisica della coppia dalle rispettive famiglie di origine, né, come per Giuliano, ad aspetti di raggiunta indipendenza economica.
Di fronte al tema della dipendenza è pertanto vitale interrogarsi su quante sfumature, talora concentriche, questo termine possa assumere nell’esistenza umana.
Ferdinando Salamino è psicoterapeuta sistemico-relazionale e insegna Psicologia e Psicoterapia all’Università di Northampton, in Gran Bretagna.
Riferimenti bibliografici
Andolfi M. (2003), Manuale di psicologia relazionale, Accademia di Psicoterapia Relazionale, Roma.
Bateson G. (1972), Verso un’ecologia della mente (trad. it.), Adelphi, Milano.
Bowen M. (1977), Family therapy in clinical pratice, Jason Aronson, New York.
Pensa C. (2018), «I significati costruiscono le sostanze?». In Storie permesse, storie proibite: vent’anni di ricerche entro la teoria delle polarità semantiche familiari, Centro Congressi Fast, Milano.
Stierlin H. (1973), «A family perspective on adolescent runway», Archives of General Psychiatry, 29, 56.
Stierlin H. (1979), Dalla psicoanalisi alla psicoterapia della famiglia (trad. it.), Boringhieri, Torino.

Questo articolo è di ed è presente nel numero 273 della rivista. Consulta la pagina dedicata alla rivista per trovare gli altri articoli presenti in questo numero. Clicca qui


