Zimbardo: alle origini dell’esperimento di Stanford
Una vecchia Hudson al Cedro Dorm
Nella sua autobiografia Philip Zimbardo rivela i retroscena scientifici e non del celebre esperimento della prigione di Stanford, e svela per la prima volta le riflessioni e le esperienze che ne hanno costituito la genesi.

Budapest, 2012. Durante un trasferimento in taxi, Philip Zimbardo sta chiacchierando con il conducente.
«Di cosa si occupa?»
«Sono uno psicologo».
Il tassista, incuriosito, pone altre domande: «Ha mai sentito parlare di quell’esperimento che hanno condotto negli Stati Uniti? Hanno davvero messo dei ragazzi in una prigione?».
Zimbardo risponde, con un certo stupore: «Sì, lo conosco molto bene!».
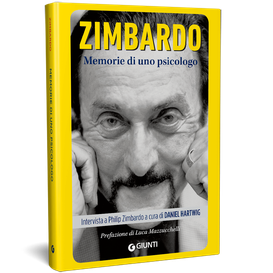 Questa conversazione è avvenuta realmente. Zimbardo ce la racconta, con la sua viva voce, nell’intervista che ha dato origine al volume, di recente pubblicazione, dedicato alle sue memorie.
Questa conversazione è avvenuta realmente. Zimbardo ce la racconta, con la sua viva voce, nell’intervista che ha dato origine al volume, di recente pubblicazione, dedicato alle sue memorie.
L’esperimento della prigione di Stanford, al quale fa riferimento il tassista, è davvero una pietra miliare della storia della psicologia, ed è così noto che, ancora oggi, suscita interesse, alimentando dibattiti e polemiche. Non è il caso di descrivere qui i dettagli metodologici, tutti ben analizzati nell’ultimo volume di Zimbardo; invece, ci piacerebbe offrire una suggestione in merito alle riflessioni e alle esperienze che hanno avuto un ruolo nella genesi di quell’esperimento. Per tali ragioni, occorre fare un balzo indietro nel tempo e tornare al 1968.
Zimbardo era stato da poco reclutato alla Stanford University, abitava al Cedro Dorm, un pensionato per studenti e, in qualità di docente residente, aveva anche la responsabilità di garantire l’adeguatezza del comportamento tenuto da quei giovani. Ma era il 1968, e quello fu un anno complesso, anche negli Stati Uniti, anche a Stanford, anche al Cedro Dorm. Gli studenti si ubriacavano, assumevano sostanze e rientravano, a qualsiasi ora della notte, bussando alla porta per farsi aprire dal Professor Zimbardo. Invero, dopo qualche tempo, iniziarono a verificarsi anche atti di vandalismo. Fu in quelle circostanze che Zimbardo ebbe un’idea, e disse agli studenti: «Se non commetterete altri atti vandalici nelle prossime due settimane, vi darò la possibilità di distruggere qualcosa». La “vittima sacrificale” era una Hudson, un’auto costruita, negli anni Quaranta, col solido acciaio di Detroit. L’idea era permettere ai ragazzi di «scaricare l’aggressività sulla macchina ed elaborare tutta l’ostilità che li animava». Quella sorta di “rito” sembrava tratto dalle pagine del Signore delle mosche: era già buio quando gli studenti, alcuni ubriachi, altri “fatti”, si avventarono sull’auto. Ma, dopo poco, la situazione precipitò: qualcuno lanciò una Molotov e la Hudson andò in fiamme. Giunsero dapprima i vigili del fuoco e poi gli agenti della polizia che tirarono fuori le armi: «Allontanatevi. Tornate nella vostra residenza! Chi è il responsabile qui?». Le fiamme si ergevano alte e brillanti, il cielo si tingeva a intermittenza di blu: c’erano lampeggianti dappertutto. La polizia era schierata di fronte agli studenti: davanti agli occhi di Zimbardo, si dispiegavano tutti gli effetti della deindividuazione.
Ci vollero altri tre anni prima che l’esperimento della prigione di Stanford venisse concepito e realizzato. Zimbardo riprodusse la situazione e la contrapposizione, che aveva osservato al “Cedro”, nello scantinato della Jordan Hall, dove era stata allestita la cosiddetta “prigione di Stanford”. In condizioni “sperimentalmente controllate”, gli studenti a cui era stato attribuito il ruolo di “guardia” si contrapponevano a quelli assegnati al ruolo di “detenuto”, e Zimbardo osservò quegli stessi effetti prodotti dalla deindividuazione e dalla depersonalizzazione istituzionale. Lo studio, che doveva durare due settimane, si concluse in maniera “turbolenta” dopo sei giorni. Peraltro, quel tempo bastò a mostrare, nel modo più evidente e drammatico, il potere della situazione: ovvero, gli effetti prodotti dalle circostanze sociali che sono in grado di alterare la personalità e il comportamento degli individui.
Al Congresso dell’APA del 1971, Zimbardo illustrò i dati dell’”esperimento” appena concluso e mostrò qualche immagine. In platea, c’era Stanley Milgram, avevano frequentato entrambi la James Monroe High School nel Bronx. Alla fine della comunicazione, Milgram si avvicinò a Zimbardo e, abbracciandolo, gli disse: «Grazie! Finalmente, mi solleverai da tutte le accuse che gli eticisti mi riservano; perché, ora è il tuo l’esperimento meno etico che sia mai stato condotto, non più il mio». L’abbraccio tra quei due vecchi amici avrebbe sancito il sodalizio tra i promotori della teoria, ancora attuale, che attribuisce potere alle situazioni.
di Massimo Simone e Raffaella Voi


