Storia di una metamorfosi
Pensieri e autocritica di una insegnante prestata per qualche tempo alla comunicazione pubblicitaria, fino a che il target a cui puntare non diventa quello dei bambini.

Appena laureata trovai delle supplenze in un liceo di scienze umane. Insegnavo psicologia e pedagogia. Una volta, dovendo sostituire una collega che aveva avuto una coppia di gemelli, rimasi sette mesi nella stessa scuola. Mi affezionai a quegli alunni e a giugno mi dispiacque che l’anno fosse terminato così in fretta. Mi proposi di riprendere a settembre e promisi ai miei alunni di tornare. In estate, però, ebbi l’incredibile fortuna di trovare un lavoro molto più remunerativo in un’agenzia di pubblicità. Era una ditta prestigiosa. I colleghi, della mia età o poco più, erano simpatici e spiritosi. Il clima di lavoro, vario e creativo. C’erano sempre delle novità. Le commesse che arrivavano erano le più varie: pubblicità di automobili, di prodotti per la casa, di giocattoli, di prodotti di bellezza e anche campagne elettorali per i candidati di turno. I colleghi che realizzavano spot per la televisione e dei videoclip erano dei geni: riuscivano a far volare le automobili, a polverizzare grattacieli, creavano mostri che per le strade di una metropoli attaccavano gruppi di extraterrestri per poi trasformarsi in lavatrici e frigoriferi.
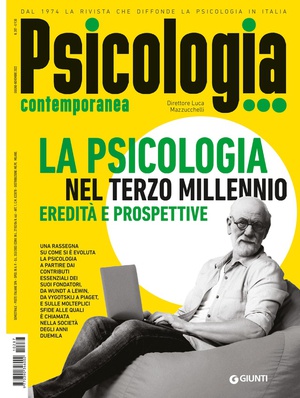
Dopo un periodo di rodaggio in cui ebbi modo di mostrare le mie competenze nel campo della comunicazione, mi fu affidato il compito di abbinare delle star del cinema, dello sport e della canzone a dei prodotti di bellezza – dentifrici, creme per il viso, prodotti per i capelli – ma anche a detersivi, biancheria intima e scarpe. Dovevo trovare gli abbinamenti giusti, inventarmi degli slogan, valutare i jingle più efficaci e alla fine sottoporre il tutto al capo. Altri colleghi, esperti in Photoshop, un programma per il foto-ritocco, si occupavano di migliorare il look della star e degli sponsor di turno. Dovevano abolire le imperfezioni della pelle, ridurre le borse sotto gli occhi, rendere i capelli più luminosi e abbondanti, i denti più bianchi e brillanti. Con qualche rapido tocco ai tasti del computer riuscivano ad allungare le gambe di una modella, a snellire le cosce, a rimodellare un didietro non abbastanza sodo o prominente.
Queste tecniche venivano utilizzate in tutti gli spot televisivi, ma anche in molti film e fiction televisive. Sia sulle attrici che sugli attori. Era eccitante vedere che cosa si poteva fare per migliorare l’immagine dei vari personaggi, comprese quelle dei politici che ordinavano spot e foto per le loro campagne elettorali. Così chiesi al capo di potermi cimentare anch’io con quelle tecniche. La mia richiesta fu esaudita con entusiasmo. «Hai talento», mi fu risposto, e io, lusingata, imparai rapidamente i trucchi del mestiere.
Raggiunto che ebbi un buon livello, mi fu affidata la responsabilità di migliorare il viso di una candidata alle elezioni politiche. Quel lavoro mi riuscì talmente bene da meritarmi gli elogi del capo e un premio di produzione a fine anno. Ero riuscita a trasformare quella candidata – che aveva gli occhi un po’ storti, il naso a palletta, i capelli radi e opachi – in una specie di fata dallo sguardo vivace e dalla chioma fluente e luminosa.
Dopo questo risultato cominciai ad avere qualche dubbio sulla bontà del mio lavoro: mi resi conto di avere contribuito a innalzare l’indice di gradimento di una candidata che non stimavo e che non avrei mai votato. Ebbi la spiacevole sensazione di aver creato una trappola con le mie stesse mani e di esserci finita dentro. Ma lasciare quel lavoro non era facile. Ondeggiavo tra il piacere di guadagnare bene e il rimorso di impegnarmi in cause che non condividevo. Ne parlai con i miei amici, i quali si divisero in due fazioni. Alcuni dicevano che ero fortunata ad avere trovato un lavoro così ben pagato e che sarebbe stato una follia lasciarlo. Di contro, altri mi facevano notare che non solo mi stavo dedicando anima e corpo a un lavoro privo di qualsiasi valore sociale positivo, ma che quel lavoro era anche intrinsecamente manipolatore.
Il dietrofront lo feci quando mi fu affidata una campagna per prodotti per la casa, «con particolare attenzione ai bambini». Il mio compito era quello di creare delle esche per convincere non solo gli adulti, ma anche i piccolissimi, a orientarsi verso determinati prodotti. «È il tuo campo» mi disse il capo.
«I bambini», mi spiegarono in un seminario, «sono i nostri agenti dentro casa, sono loro che assillano i genitori e li spingono ad acquistare sia i prodotti che li riguardano, come giocattoli, cellulari e abiti, sia prodotti per la casa e la famiglia, come elettrodomestici, alimenti, pentole, creme, dentifrici, divani». Dissero anche che questo assillo ha un nome in inglese, “nag factor”, che tutti i pubblicitari conoscono. Aggiunsero che il mio lavoro sarebbe stato quello di “fidelizzare” i bambini fin da piccolissimi ai loghi, in modo che vi si legassero emotivamente. «Il brand, prima ancora del prodotto, dev’essere riconosciuto dal bambino come un oggetto buono che trasmette emozioni positive: protezione, affetto, divertimento, benessere. A 3 anni, ancor prima di saper leggere, un bambino può infatti fare richieste specifiche pronunciando il nome e la marca del prodotto che ha visto tante volte sullo schermo». Infine, «Tra gli 8 e i 12 mesi i piccoli che vengono esposti al televisore cominciano a formarsi immagini mentali delle marche e dei personaggi associati ai vari prodotti».
Uscii turbata da quel seminario. Mi dissi che non potevo, per vendere dei prodotti, infinocchiare gli spettatori, in particolare i bambini, ingenui e tanto fiduciosi negli adulti. Non potevo passare il mio tempo a escogitare strategie per convincerli di aver bisogno di qualche cosa di cui non avrebbero sentito l’esigenza se qualcuno non li avesse condizionati a desiderarla. Né potevo più accettare che star, sportivi e cantanti dal look pesantemente ritoccato facessero sentire inadeguati spettatori che guardandoli si convincevano (e continuano a convincersi) di non essere che una pallida copia di quei divi.
Sono dunque tornata all’insegnamento con uno stipendio assai inferiore a quello dell’agenzia, ma con la gioia di non ingannare nessuno e di lavorare insieme ai ragazzi per il loro sviluppo cognitivo e la loro formazione culturale. Sono entrata in graduatoria. Spero prima o poi di vincere un concorso.
Anna Oliverio Ferraris, docente universitario, scrittrice, psicoterapeuta. Collabora con questa rivista dal 1975. Scrive sulle riviste Mind, UPPA, Conflitti e tiene la rubrica «Gli anni della crescita» sulle sue pagine Facebook. Pubblicazioni recenti: Chi manipola la tua mente? (Giunti); Più forti delle avversità (B&B); Sopravvivere con un adolescente in casa (BUR); Tutti per uno (Salani), un romanzo che descrive la formazione di un gruppo di adolescenti costruttivo e resiliente.

Questo articolo è di ed è presente nel numero 279 della rivista. Consulta la pagina dedicata alla rivista per trovare gli altri articoli presenti in questo numero. Clicca qui


