Recensione "Dogman". Un film di Matteo Garrone
Le varie facce della violenza che può esplodere nel non-luogo di una periferia italiana degradata, alle prese con un soggetto che trasgredisce sistematicamente le regole della comunità.
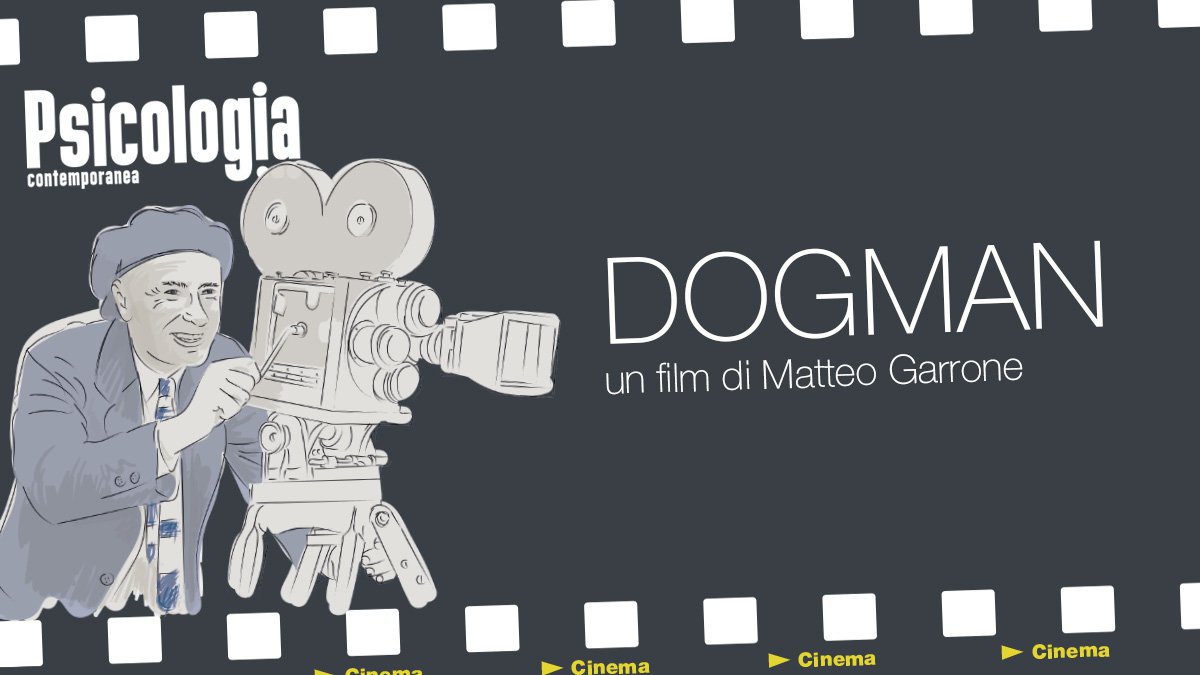
Dogman (Italia, 2018, 120’) sta tutto dentro lo squallore di una periferia, chiuso in un’ultima frontiera. Anche per questo Matteo Garrone parla del suo film come di un western. Non si tratta però di una frontiera aperta sul possibile, su un’alterità tutta da scoprire, come nel western del mito, ma di un limite estremo in bilico sul niente. In questo non-luogo, vuoto di umanità e colmo di palazzoni sventrati, Marcello (Marcello Fonte) vive una piccola vita.
Garrone e i suoi cosceneggiatori, Ugo Chiti e Massimo Gaudioso, ne traggono liberamente la storia da quella del Canaro, come trent’anni fa giornali e televisioni chiamarono Pietro De Negri. Toelettatore per cani della Magliana, nel 1989 De Negri fu condannato per l’omicidio di Giancarlo Ricci, un ex pugile dilettante di cui era stato complice in una rapina.
Ai giudici “er Canaro” disse di averlo torturato per ore, di averlo mutilato più volte e solo dopo di averlo ucciso. Ma non è la sua confessione, forse una millanteria, che interessa a Garrone, e nemmeno il fatto del crimine. Il Marcello di Dogman non è il Canaro della Magliana. La vicenda di questo vale solo come pretesto realistico su cui sceneggiatura e regia innestano un testo irrealistico, in accordo con la poetica dell’autore di Gomorra (2008) e di Reality (2012).
Come spesso capita in un western, in Dogman c’è una piccola comunità chiusa, egoista e imbelle, che deve sopportare la prepotenza di un eccedente, cioè di qualcuno che, pur stando al suo interno, si pone contro le sue regole e ne mette in crisi l’ordine. In questo caso si tratta del grosso e violento Simoncino (Edoardo Pesce), ispirato anch’egli molto liberamente a Ricci.
Ancora come in un western, non c’è chi voglia e possa ristabilire la normalità. Di questo si lamentano i bravi cittadini, del fatto che nessun uomo della legge li liberi dalla belva che si muove tra loro e che nessun tribunale li vendichi. Qualcuno progetta di chiamare «gente da fuori», professionisti grossi e violenti più di Simoncino che facciano il lavoro sporco. Ma c’è chi si oppone. Prima o poi, Simoncino finirà ammazzato. Meglio aspettare, subire, sperare, senza rischiare. Gli uni e gli altri sono il misero, squallido coro tragico che accompagna il racconto. Così accade per lo più nel western, il cui mito fa rivivere in qualche misura l’epica e la tragedia, e le intreccia.
Quanto a Marcello, è il fragile, indifeso protagonista/eroe: un eroe paradossale, un doppio mimetico dell’antagonista/antieroe, succubo della sua incontenibile violenza distruttiva, e insieme da essa affascinato. Simoncino attrae e respinge Marcello al pari del mastino ringhioso che lava all’inizio del film: lo tiene ben legato al muro, e lo tocca e lo accarezza, intimorito dalle fauci bavose che scattano, estasiato dalla loro ferocia.
I due, il fragile Marcello e il possente Simoncino, vivono nella stessa dimensione di amoralità inconsapevole, e in questo senso senza colpa personale. Così li dobbiamo guardare, così li dobbiamo sentire nella nostra emozione, non come personaggi della realtà, da giudicare dall’esterno, ma come portatori necessari di una hybris, di una tracotanza che contraddice l’ordine dell’universo, o almeno dell’universo minimo chiuso nello squallore irrealistico della Magliana di Garrone.
La tracotanza e l’eccedenza di Simoncino sono dirette, agite con la brutalità di una bestia selvaggia. Quelle di Marcello sono indirette, come se ne fossero le immagini allo specchio. Ciò che li rende differenti, la potenza fisica smisurata dell’uno e la fragilità radicale dell’altro, li accomuna però nei confronti dei cittadini/coro, cioè li fa egualmente diversi nei confronti della loro normalità impaurita. Prevalga Simoncino su Marcello, o Marcello su Simoncino, il loro fato è segnato. Sono eccezioni, contraddicono la medietà, saranno gettati al di là della frontiera di quel non-luogo di case ridotte a scheletri e fantasmi.
Tra l’eroe e l’antieroe, la macchina da presa di Garrone sembra esitare, incapace di privilegiare l’uno o l’altro. In Simoncino intuisce e racconta una massa di carnalità distruttiva, un grumo oscuro di prepotenza che non conosce parola, cieca e muta com’è solo la morte. E ne è turbato, anzi ne è succubo e preso almeno quanto ne è turbato, succubo e preso Marcello. In Marcello, invece, intravede e immagina una delicatezza imprevista, una dolcezza paradossale, una volontà e un bisogno irriducibili d’amore: per la figlia, per i suoi cani, anche per Simoncino.
Una volontà e un bisogno che potrebbero sottrarlo alla ananke, alla necessità e al fato che pesano su di lui. Ma non c’è epica tragica, non c’è western senza necessità e fato. Alla fine del racconto, si compie quanto da sempre deve accadere. Le due smisuratezze si scontrano, opposte e speculari, e l’eroe prevale sull’antieroe. La comunità di imbelli è stata liberata, ma l’eroe liberatore non trionfa. Non c’è posto nel coro, per lui, ma abbandono e solitudine, al di là della frontiera e sprofondato nel niene
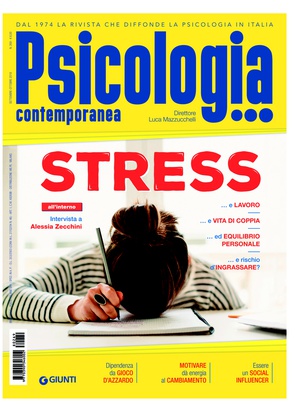
Questo articolo è di ed è presente nel numero 269 della rivista. Consulta la pagina dedicata alla rivista per trovare gli altri articoli presenti in questo numero. Clicca qui


