Lo sport ci rende migliori?
L’attività sportiva è sempre benefica? Dipende da quello che ricerca chi la pratica: performance, equilibrio o padronanza di sé.

Difficile sfuggire allo sport. Quando le grandi maratone internazionali radunano migliaia di praticanti, la televisione trasmette continuamente spettacoli sportivi e lo sport etichetta oggetti e attività lontanissimi dai campi di gara (profumi, automobili, atteggiamenti, problemi esistenziali), fino allo “sport da camera da letto”, sembra che lo sport sia diventato ormai un “fatto sociale totale”, secondo la definizione di Marcel Mauss.
Tuttavia, per chiarezza semantica, è il caso di ricordare che non tutta l’attività fisica è sport, così come lo sport non è solo quello veicolato dai media. Da un lato, lo sport in senso stretto è un’attività nata nel XIX secolo da un progetto di riforma pedagogica e morale, si è realizzato in competizioni istituzionalizzate ancora in vigore ai nostri giorni, il che esclude per definizione attività fisiche come coltivare l’orto o salire le scale.
Dall’altro, quello di cui si occupano i media è lo sport di altissimo livello, una sfera totalmente a sé, distinta sia dalla tradizione dell’educazione fisica che dalle attività sportive del tempo libero. Queste distinzioni sono importanti per capire il tipo d’interesse che ciascuno investe nello sport e gli eventuali vantaggi che può sperare di ricavarne.
Cinque ore di nuoto settimanali per ragioni di salute o quaranta ore di allenamento per partecipare alle olimpiadi non comportano le stesse aspettative, né gli stessi effetti: una differenza quantitativa che diventa qualitativa e mette in discussione i “benefici” dello sport.
Se può dar luogo a una tale passione esclusiva, ma è anche prescritto dal medico, se, parafrasando il Sisifo di Camus, l’uomo deve immaginarsi “sportivo felice”, se il campione, infine, è un eroe della modernità, dovremo domandarci in che senso lo sport può renderci migliori e quale significato ciò rivesta nella nostra vita: virtù morale, successo, fantasma igienista, realizzazione spirituale?
Il termine “migliori” corrisponde qui agli scopi molteplici – militari, medici, pedagogici, competitivi – che l’esercizio fisico ha fino dall’antichità classica: migliori di chi? Migliori di cosa? Si avverte una gradazione di pratiche e di risposte fra la connotazione etica mirata all’interiorità e la performance che implica rivalità, fra l’ideale olimpico di de Coubertin e i dispositivi digitali destinati a chi fa sport.
Quali sono le motivazioni che ci spingono a correre nei parchi o sul tapis roulant, ad avventurarci nella maratona o nella corsa campestre? Cosa rivela questa passione competitiva che ci costringe a superare noi stessi, sul campo o di fronte a uno schermo? Perché soffrire per godere infine il piacere dello sforzo estremo? Laboratorio del sociale, lo sport è anche il terreno di un’esperienza esistenziale, che mette a confronto con se stessi e, come scriveva Spinoza, con «ciò di cui è capace il corpo umano». Sono queste le variabili che ci interessano qui, per distinguere i tipi di eccellenza possibili in un’attività proteiforme, e il senso che rivestono.
AMBIVALENZA DELL'ECCELLENZA
L’antichità greca non è solo la fonte remota dei Giochi Olimpici, ma ci rimanda alla questione fondamentale del senso di eccellenza: prestazione eroica o giusta misura. Nei poemi omerici, testi per molti versi d’ispirazione “sportiva”, l’eccellenza (aretè) implica grandezza, la superiorità si fonda sulla vittoria e lo statuto eccezionale dell’eroe presuppone virtù morali e fisiche. Eccellere significa essere il migliore e nel conseguimento di questa posizione di privilegio interviene senza dubbio l’addestramento fisico. In Aristotele invece non ha posto l’eroismo atletico, ma un’altra visione dell’eccellenza. Nell’Etica nicomachea essa significa misura, il “giusto mezzo in relazione a noi”. In altre parole, la prudenza condiziona la saggezza, la quale tuttavia non è accessibile a tutti.
L’eccellenza presuppone il kairos, il momento esatto e raro dell’azione, simboleggiato dall’arciere che coglie nel segno. È una visione della giusta misura che è selettiva, aristocratica (in questo vicina alla concezione omerica della grandezza), non priva di un risvolto estetico. Non c’è traccia di eccessi, di superomismo né di dominio sugli altri nella visione aristotelica, ma una cultura dell’equilibrio, dell’armonia con se stessi e con la natura, che ha la sua controparte medica nell’opera di Ippocrate.
Sono due concezioni dell’eccellenza che creano un’ambivalenza filosoficamente feconda nella definizione di ciò che è bene: quella fra buono e migliore, fra limite e illimitato, fra equilibrio ed eccesso, fra salute e performance, fra realizzazione e superamento.
Questa ambivalenza si incarna in maniera emblematica nella storia della ginnastica, dell’educazione fisica e dello sport, una storia che da sempre oscilla tra finalità che mirano a un sano equilibrio o al continuo superamento dei limiti. “Migliorare” può quindi significare star bene in un progresso fisico e psicologico di cui render conto solo a se stessi, o far meglio nel senso di superare se stesso e gli altri.
È una sfumatura sottile, che a volte diventa un abisso incolmabile: nella sua cultura dell’eccesso e nell’intensità dei carichi di lavoro che impone, lo sport di eccellenza rompe con qualunque idea di giusta misura, come testimonia il corpo ipertrofico, dopato, indebolito di certi atleti o le catastrofiche riconversioni a cui sono esposti.
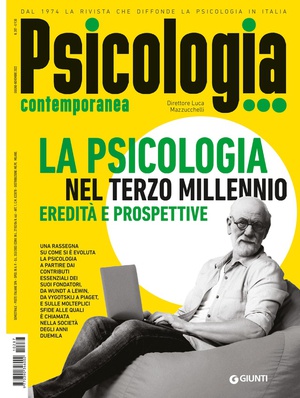
QUANDO ESSERE MIGLIORI SIGNIFICA MIGLIORARE INDEFINITAMENTE
Il mondo greco concepiva il superamento di sé solo entro limiti normativi insuperabili: quelli della legge, del cosmo e del divino. Non lo vedeva come facciamo noi, né lo teorizzava come un’idea-forza. “Superarsi all’infinito” non era un concetto legittimo, perché sull’infinito prevaleva il finito, il completo, il realizzato, cioè il perfetto, mentre progredire indefinitamente avrebbe significato superare i limiti naturali, agire “contro natura”, a rischio della follia. Lo stesso concetto di performance in quella concezione era circoscritto a quanto autorizzato da ordini esterni.
Ben diverso è il contesto della modernità. La rivoluzione copernicana, la scienza nuova di Galileo, la sfida cartesiana di “renderci signori e padroni della natura”, infine la straordinaria fecondità – pedagogica, medica e politica – dell’idea illuministica della perfettibilità umana, conducono al progetto di miglioramento dell’individuo e della specie. Il progresso diventa potenzialmente illimitato, ribaltando i valori tra finito e infinito, la natura diventa trasformabile e la misurazione (statistiche, rilevamenti strumentali) è il parametro principe di tale processo.
È in questo contesto che a metà del XIX secolo nasce lo sport moderno propriamente detto. Dapprima voleva essere un progetto pedagogico, avviato a fini politici da educatori come il reverendo Thomas Arnold, che nel 1828 divenne rettore della rugby School (il college dove si dice sia stato inventato l’omonimo gioco). Al gioco sportivo – prima come football rugby, poi come football – si attribuiscono virtù morali che rappresentano anche valori di ordine e di gerarchia sociale intesi come meritocrazia: sviluppo dell’autocontrollo, rispetto dell’altro, solidarietà, emulazione e superamento di sé.
Il successo non tarda: le discipline sportive si moltiplicano, dilagano fuori dalle isole britanniche e seducono osservatori come Pierre de Coubertin o Hippolyte Taine, affermandosi come passatempo privilegiato, strumento educativo e infine, nel XX secolo, come spettacolo universale.
È indubbio che la posta in gioco sia di ordine morale. Il gioco rende migliori in quanto promuove virtù (che poi si chiameranno “sportive”): conviene agli aristocratici, ma anche alla borghesia in ascesa che ne adotta la meritocrazia intrinseca, come alle masse lavoratrici che vi incanalano (e moltiplicano) la loro energia.
In quanto strumento dell’ordine sociale, lo sport contribuisce al patriottismo e alla formazione della gioventù, nel momento in cui l’Europa è minacciata dalle guerre. Assolve anche a finalità di tipi igienico-sanitario, benché de Coubertin, in contrapposizione per esempio alla tradizione salutista della ginnastica svedese, insista soprattutto sugli aspetti ludici e pedagogici.
Questi tuttavia nascondono alcune fratture teoriche. La prima nasce dal fatto di aver fondato lo sport sul superamento di se stessi, in un’epoca in cui il miglioramento dell’uomo cerca di concretizzarsi nella tecnica. Già alla fine del XIX secolo lo sport è un oggetto di laboratorio (per esempio nella Stazione fisiologica del Parco dei Principi, a Parigi), paragonabile alle ricerche sulla produttività del lavoro industriale: ergonomia del corpo umano in fabbrica e negli stadi, promozione di un evoluzionismo schematico che ha per emblema il record, scissione fra l’ideale di una pedagogia globale di base incarnata nell’educazione fisica e la specializzazione esasperata dello sport competitivo (Hebert, 1925). Da allora il progetto di miglioramento umano si esprime nel motto dei giochi olimpici, Citius, Altius, Fortius: più veloce, più alto, più forte.
La seconda frattura è contenuta in germe nella competizione sportiva. Lo si avverte già nelle parole di de Coubertin, quando evoca «la libertà di eccesso» che a suo dire definisce lo sportivo autentico (de Coubertin, 1931). Negli anni Sessanta del secolo scorso nasce lo sport di élite, con la mondializzazione e la copertura mediatica delle gare, con la professionalizzazione degli atleti, l’intensificarsi degli allenamenti, la medicalizzazione sistematica e sofisticata della preparazione atletica. Le prestazioni fisiche non conoscono limiti, il mondo delle cifre è il loro terreno naturale. Ormai lo sport di alto livello non ha più niente in comune con lo sport di massa, evolve in una sfera in cui tutti i parametri – materiali, tecniche, preparazione medica, dietetica, psicologica, doping – sono ottimizzati fino a fare del campione un prototipo umano.
Non si può non riconoscere in questa ossessione del progresso un’incarnazione dell’ideologia illuministica e più in generale della modernità. Ma nemmeno si può negare che, in vista del momento della vittoria, in questo superamento estremo vi sia anche una forma di autorealizzazione, un modo di accedere a sé, di farsi più grande, di “elevarsi”, come preconizzato da de Coubertin. La vittoria è ambigua, fatta di consacrazione oggettiva (il risultato) e di esperienza soggettiva: felicità e insoddisfazione estasi e mancanza.
Quanto all’idea di perfettibilità, si è evoluta, dal concetto rousseauiano di affrancamento morale e politico a quello di perfezionamento biotecnico dell’uomo, dal positivismo ottocentesco di Auguste Comte fino al giorno d’oggi. Lo sport d’élite nell’era della tecnologia finisce per tradurre questo sogno di superumanità.
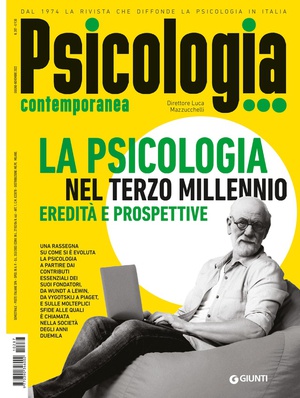
PADRONANZA E COSCIENZA DI SÉ
La “sportivizzazione dei costumi e dei corpi” in atto ai nostri giorni deve molto alla capitalizzazione di sé e del tempo descritta da Max Weber: se “il tempo è denaro”, è anche innegabilmente forma fisica, salute, prestazioni e lotta contro l’invecchiamento. Questa visione capitalistica dei nostri sforzi atletici e dei benefici che ne aspettiamo è illustrata dal successo commerciale di dispositivi elettronici come i braccialetti fitness, che registrano momento per momento attività fisica e parametri fisiologici, vere e proprie icone del quantified self. Riflesso dell’ossessione contemporanea per la quantificazione e del fascino che esercita la misurazione di sé, ma anche strumento di autocontrollo, il gadget rinnova l’adagio “lo sport è salute”, promuovendo il miglioramento costante di sé.
Contabilizzare ogni giorno i propri minimi gesti, obbedire alla sveglia che intima “Alzati!”, partecipare a comunità virtuali di confronto, sentirsi incitare fino nei mezzi pubblici a fare i nostri 10.000 passi quotidiani: si è aperta una nuova era di democratizzazione dell’osservazione infinitesimale della salute, riservata un tempo agli atleti professionisti. Può darsi che la misurazione universale sognata dal XIX secolo abbia trovato qui un inedito trionfo.
Non è chiaro se l’uso medico di questi dispositivi di (auto)sorveglianza sia più da temere o da apprezzare. Si potrebbe anche immaginare, contro la paura di ogni quantificazione, che dall’attenzione costante al proprio sforzo fisico si sviluppi un atteggiamento “amichevole” verso se stessi: l’idea di un’articolazione positiva tra la promessa di un autocontrollo algoritmico e una migliore autocoscienza non è del tutto assurda e merita di essere scavata più a fondo.
Inoltre, se è vero che il superamento dei propri record personali è l’essenza dello sport professionistico, non ne è monopolio esclusivo. Chiunque faccia una pratica atletica sia pure modesta, si sia impegnato allo spasimo in una partita di tennis o di calcetto, si sia lasciato tentare da un salto con il paracadute, ha fatto questa esperienza inquietante, che può diventare compulsiva: imporre la propria volontà alla fatica, alla paura, al dolore, alla pigrizia, alla rinuncia, a un comodo benessere fisico e mentale, spingendosi “più lontano, più alto, più forte” per raggiungere un’altra riva.
Che si traduca in una vittoria o semplicemente nell’esperienza dello sforzo, magari dell’ultimo arrivato che riesce a portare a termine comunque la sua prima maratona, il superamento di sé è una scoperta: «Non me ne credevo capace e ce l’ho fatta, l’ho sempre sognato ma non mi ero mai messo alla prova». In un certo senso posso dire di essere paradossalmente “più forte di me”. Da qui la formula, certamente impropria, del “superamento dei limiti”.
È un’esperienza che chiama in causa non solo lo sforzo, i limiti fisici e psichici delle prestazioni, ma anche per qualche verso la conoscenza di sé. Quella che nello sport competitivo Claire Carrier (1992) ha chiamato «effrazione della propria normalità» è tuttavia un’esperienza aperta a tutti, che può essere affascinante: l’ampliamento della conoscenza e del riconoscimento di sé che si realizza nello sforzo fisico. Al di là dei meccanismi fisiologici attivi nello sforzo intenso e prolungato, in particolare la produzione di adrenalina e di endorfine (gli “ormoni del piacere”), il superamento dei propri limiti personali mette in luce una verità teorica centrale nello sport in senso lato: lo sforzo chiama al superamento dello sforzo.
È un’idea che richiama il concetto fondamentale della psicologia volontaristica di Maine De Biran: la coscienza di sé è in primo luogo coscienza del corpo, che oppone resistenza, resistenza che si supera mediante lo sforzo. Con le sue riflessioni sulla natura dello sforzo, come realizzazione di ciò che è già presente nel proprio essere o come superamento e creazione del nuovo, il filosofo antilluminista anticipava una fenomenologia dello sforzo atletico come ampliamento di sé.
Essere migliore significa quindi anche conoscersi meglio: l’esperienza sportiva – allenarsi, piegare il corpo a una disciplina, lavorare sugli automatismi, vivere la temporalità specifica dello sforzo, che per definizione proietta fuori dal momento presente – contribuisce senza dubbio, al di là dell’articolazione ambivalente tra piacere e dolore, a realizzare una migliore autoconoscenza. C’è un’altra pratica che punta alla conoscenza di sé a partire dal corpo, ma in un quadro temporale del tutto diverso e senza alcuna volontà di prestazioni: la meditazione trascendentale.
«Ciò di cui è capace il corpo umano», secondo la formula di Spinoza, è quindi di una varietà estrema, ma con una costante: lo sforzo fisico dispiega il sé, come il passo che nel cammino o nella corsa sembra dispiegare il pensiero. Tutt’altro che impermeabile ai temi del suo tempo, lo sport finisce forse per esserne definito: non sorprende che alle virtù tradizionalmente attribuite all’attività fisica nel campo della formazione morale si aggiungano oggi gli obiettivi della salute, delle prestazioni, dell’eterna giovinezza.
Lo sport non ci rende migliori per certe sue qualità intrinseche; se lo fa è indubbiamente perché mette in scena il nostro rapporto con il corpo. In questo copione emergono questioni filosofico-esistenziali (eccellenza, sforzo, salute, piacere e dolore, potenza e impotenza, corporeità), sociali (valori della performance e della competizione, merito, superamento di sé), scientifiche e politiche (miglioramento della specie e valutazione sofisticata delle attitudini).
Lo sport offre un’esperienza singolare di immersione nella resistenza materiale che il corpo oppone alla creatività personale. Quello di automatismo diventa qui un concetto chiave, in quanto evidenzia la nostra esperienza interiore della libertà e dell’alienazione. Si tratta infatti di esercitarsi, indefinitamente, per conquistare una sensazione fugace di grazia e di facilità. Fare sport è sempre un po’ un uscire da sé ma per ritrovarsi, riconoscersi e allargare il campo della coscienza: una possibilità di miglioramento tanto fisico che spirituale.

Questo articolo è di ed è presente nel numero 253 della rivista. Consulta la pagina dedicata alla rivista per trovare gli altri articoli presenti in questo numero. Clicca qui


