L’eredità dei padri fondatori
Il lavoro dei capiscuola della psicologia, come Wundt, Lewin, Piaget o Vygotskij, rappresenta un patrimonio attivo e spendibile per la psicologia contemporanea, a partire dalla sinergia tra ricerca sperimentale e metodi applicativi. Lo evidenzia una sintetica rassegna dei grandi nomi, delle principali correnti e delle loro applicazioni, anche nello specifico contesto italiano

«Ciò che avete ereditato dai padri riconquistatelo, se volete possederlo davvero», scriveva Wolfgang Goethe. Nella psicologia contemporanea cosa resta di quella delle origini? Quale eredità possiamo raccogliere dai padri della psicologia che nella prima metà del secolo scorso la resero scienza autonoma?
Riprenderemo sinteticamente alcune figure esemplari, scegliendole fra le tante che hanno costruito la psicologia moderna, e lasciando qui da parte il campo della psicologia dinamica e clinica che merita un discorso a parte. Di questi autori selezionati considereremo il lascito storico sul piano epistemologico e metodologico, in funzione dell’integrazione della psicologia con le scienze cognitive contemporanee.
PARTIAMO DALLE ORIGINI
Il fisiologo Wilhelm Wundt è considerato il fondatore della psicologia come disciplina autonoma per aver applicato l’approccio tipico del laboratorio ad oggetti psicologici come i processi mentali. Ma il suo metodo, applicato a un oggetto che coincideva con il soggetto, doveva andare oltre le misurazioni psicofisiologiche e i tempi di reazione: richiedeva la valutazione introspettiva dell’esperienza. Si delineavano così due tipologie di scienza psicologica: quella collocabile all’interno delle scienze della natura, che studia le sensazioni e le variabili psicofisiche, e quella che si occupa degli atti volitivi e delle decisioni morali, del ragionamento e del linguaggio, fino alle creazioni artistiche, che fa parte delle scienze “dello spirito”.
Questa dicotomia è ancora presente nella psicologia contemporanea, tra il metodo sperimentale che trova consonanza nella psicobiologia e nelle neuroscienze, e quello psicosociale per lo studio della personalità nello sviluppo tipico e atipico, che necessita di un metodo di studio diverso ed ha diverse finalità e modalità applicative.
FUNZIONI OLTRE CHE STRUTTURA
Intanto, già alla fine dell’Ottocento, oltreoceano – dove Titchener aveva esportato le teorie di Wundt – William James e John Dewey ridimensionavano il ruolo dell’introspezione, cui associavano l’osservazione comportamentale, applicandola anche al di fuori del laboratorio.
L’osservazione dei bambini in un ambiente naturale, come quello scolastico, consente di studiare come funziona l’apprendimento, integrando le diverse competenze che in laboratorio è possibile valutare separatamente. L’ottica strutturalista di Wundt viene integrata da quella funzionalista, mediante la quale si può analizzare il flusso continuo della coscienza, non frammentabile se non in modo artificiale. Quest’ottica facilita le applicazioni scolastiche, ma anche sociali e cliniche cui i pragmatisti James e Dewey erano particolarmente interessati.
L’attualità di questi autori è evidente nel dibattito odierno tra lo sperimentalismo di laboratorio e l’integrazione di metodi quantitativi e qualitativi, capaci di perseguire appropriatamente gli obiettivi applicativi che la psicologia deve proporsi per rispondere alle richieste sociali.
LA FENOMENOLOGIA DELLA GESTALT
L’introspezionismo wundtiano, oltre che dal funzionalismo e dal radicalismo behaviorista, fu contestato in Europa anche dalla scuola della Gestalt. I suoi fondatori (Wertheimer, Koffka, Köhler), ai primi del Novecento rivendicavano in ottica fenomenologica l’importanza di cogliere il vissuto esperienziale, cioè l’esperienza diretta, non mediata dall’introspezione. Questo metodo consente di contestare anche l’altro caposaldo delle teorie wundtiane: l’elementismo. La sensazione derivante dagli elementi fisici viene superata dalla percezione fenomenica dell’esperienza, che ne svela la “forma” globale, in un tutto che è diverso dalla somma delle parti. Il globalismo olistico dell’approccio della Gestalt conferma che le qualità dell’esperienza appartengono non agli elementi ma alla relazione fra essi. I campi percettivi e cognitivi assumono regole proprie, più forti di quelle dell’apprendimento. Lo studio dell’insieme, ove assuma caratteri di complessità e dinamicità, può essere non frazionabile (se non arbitrariamente) e non quantificabile.
Gli esperimenti di Köhler sull’insight confermarono che la soluzione di problemi “situati” in un campo cognitivo può avvalersi, in alternativa al metodo di prova ed errori non sempre efficace, della riorganizzazione funzionale degli elementi del campo in una Gestalt significativa.
Le teorie sul pensiero produttivo di Duncker confermano che la ristrutturazione flessibile degli elementi del campo è alla base del pensiero “divergente”, utile quando le soluzioni analitiche e algoritmiche sono meno proficue o addirittura impossibili. Su questi principi gestaltici si basarono teorie della creatività e della produzione artistica ancor oggi condivise.
All’epistemologia gestaltica viene spesso associato Kurt Lewin che si è proposto di studiare il campo cognitivo, e le forze che agiscono in esso, con un metodo che si avvalga dell’azione come strumento di conoscenza e non solo come applicazione di teorie studiate in laboratorio.
Cosa ci resta della lezione della Gestalt e dell’apporto metodologico lewiniano allo studio dei campi di esperienza? L’importanza attribuita alla relazione tra le parti nel formare la struttura dell’esperienza, e all’azione come strumento essenziale di conoscenza, trova riscontri nelle moderne teorie della complessità, e nei network neurali riproducibili nelle reti artificiali. L’emergere dell’esperienza come fenomeno unitario rivaluta la fenomenologia come metodo capace di superare il riduzionismo della conoscenza degli oggetti psicologici.
La soluzione dei problemi come ristrutturazione dei dati dell’esperienza, oltre che come somma di specifici apprendimenti, ha aperto le porte alle attuali teorie dell’intelligenza e della sua misurazione in termini qualitativi piuttosto che esclusivamente quantitativi. Su questo aspetto ci soffermeremo ricordando l’apporto di Piaget, derivante da basi teoriche e metodologiche diverse ma per molti versi convergenti.
QUALITATIVO OLTRE CHE QUANTITATIVO: L’EPISTEMOLOGIA GENETICA
Partito dallo studio delle scienze naturali, Piaget rifiuta il riduzionismo positivistico, e da pioniere della filosofia della scienza si occupa dello studio delle forme di conoscenza e della loro evoluzione, fondando quella che viene definita “epistemologia genetica”.
Per questa disciplina aspetto essenziale è, ancora una volta, il metodo. La studio dello sviluppo cognitivo era affidato allora alle tecniche psicometriche di valutazione dell’intelligenza, che Binet e Simon in Francia, e poi Terman negli Stati Uniti, centravano su prove di livello evolutivo (definite appunto di “età mentale”) da cui ricavare il quoziente intellettivo confrontandone i risultati con l’età cronologica del bambino. Lo psicologo ginevrino contestava il fatto che per capire come pensa una persona bastasse questo approccio quantitativo, che considera solo l’esito del processo di risposta alle prove del test. L’essenziale è invece comprendere come funziona il processo stesso: come pensa il bambino ad una certa età, quali sono le tappe evolutive di questo pensiero che solo un approccio qualitativo può cogliere pienamente. Piaget è il capostipite delle critiche che successivamente sono state rivolte ad un approccio puramente psicometrico alla valutazione dell’intelligenza. A questo pioniere della psicologia moderna si devono il metodo “clinico”, cioè personalizzato e qualitativo, per l’esame dei fenomeni psichici, e i risultati che questo metodo ha consentito di ottenere e che sono ancora oggi alla base della comprensione delle modalità in cui funzionano il pensiero, l’affettività e la socializzazione nelle diverse fasi dello sviluppo.
LA MENTE STA NEL SOCIALE
L’evoluzione delle forme di conoscenza è pure l’oggetto di studio di un altro grande padre della psicologia della prima metà del secolo scorso, Lev Vygotskij. Il quale, pur provenendo dalla riflessologia, si inquadra nella scuola storico-culturale russa e considera la mente umana come una entità radicalmente sociale e storica. La mente non è racchiusa dentro il corpo individuale, ma coincide con l’insieme delle relazioni storico-sociali che quel corpo intrattiene con il suo ambiente. Si ritrovano tracce di questo radicale anti-dualismo nelle moderne teorie neuroscientifiche? Per riscontrare illuminanti consonanze si potrebbe partire dalla famosa critica del dualismo cartesiano mente-corpo da parte di Damasio, fino alle neuroscienze sociali e alla recente epigenetica, che considera l’evoluzione determinata geneticamente nel rapporto con l’ambiente che attiva o disattiva specifiche funzionalità dei geni. La mente si sviluppa nella cultura (questo lo sapeva bene la psicologia sociale e dello sviluppo fin dalle origini), ma l’apporto culturale modifica anche l’assetto biologico geneticamente condizionato. Già un secolo fa Vygotskij avrebbe sottoscritto queste conclusioni cui era pervenuto studiando con metodi psicologici (né solo fisiologici, né solo sociali) come si sviluppano il pensiero, il linguaggio e la coscienza umani.
Fermiamoci qui nel ricordo di figure pionieristiche della psicologia internazionale, perché lo scopo di queste pagine non è rifare in pillole la storia della disciplina, seppure limitata alla prima metà del Novecento, e volutamente omettendo la psicologia clinica. L’obiettivo è riscoprire cosa resta della lezione di questi “padri”, il cui ricordo talvolta si appanna, mentre tanto hanno da suggerirci rispetto ai dibattiti attuali sui metodi e sull’epistemologia della scienza psicologica quando si confronta con neuroscienze, intelligenza artificiale, teorie della complessità e loro applicazioni.
E IN ITALIA?
Proprio le applicazioni e i metodi per assicurarne la scientificità sono il fulcro della seconda parte di questa sintetica rassegna, dedicata alla psicologia nel contesto italiano, che fin dalle origini ha integrato il metodo sperimentale di laboratorio con quello applicativo al contesto sociale.
L’eredità che ci resta dai padri della psicologia italiana della prima metà del Novecento riguarda il fatto che la prassi psicologica non è solo un’applicazione di principi generali studiati e convalidati in laboratorio, e supera il dualismo tra chi “fa” e chi “fa ricerca” tipico di altre scienze (genetica, medicina di base, fisica ecc.).
La prima rivista psicologica italiana dell’era moderna, prima di assumere nel 1912 il nome di Rivista di psicologia, era stata fondata nel 1905 da Giulio Cesare Ferrari come Rivista di psicologia applicata alla pedagogia e alla psicopatologia. Fra i temi trattati troviamo la psicologia del lavoro e la psicotecnica, la psicologia militare, gli aspetti applicativi del sapere psicologico: educativi, psichiatrici, criminologici e istituzionali. La psicologia italiana fin dalle sue origini metteva la propria scienza al servizio dei bisogni sociali.
I laboratori di psicologia erano aperti alla coabitazione e alla commistione con l’esterno.
In quello di Padova Vittorio Benussi praticava sia la metodologia sperimentale sia la ricerca applicata ai temi della suggestione ipnotica e della psicoanalisi.
A Milano Agostino Gemelli – in tempi difficili per la psicologia, ostracizzata dalla cultura idealista e dal potere fascista – affermava che lo spirito di ricerca critica si esplica soprattutto nel confronto con i problemi della realtà sociale, che erano la psicologia militare, l’operaio nell’industria moderna, la personalità del delinquente e, ancora, la selezione del personale e l’orientamento. Il laboratorio era per Gemelli il prodromo per l’uso dei dati delle ricerche sperimentali in contesti sociali: come ricordava Enzo Spaltro, ogni nozione teorica provocava subito in lui il problema della applicabilità pratica.
A Firenze nel periodo fra le due guerre il laboratorio di psicologia sperimentale fondato da De Sarlo era fecondo di applicazioni: Sarfatti e Bonaventura studiavano la possibilità di usare i dati psicologici per la psicologia militare e per l’orientamento professionale. Nello stesso periodo a Roma Sante De Sanctis, titolare della cattedra di psicologia sperimentale, si impegnava in applicazioni all’assistenza e al recupero dei «minorenni poveri e minorati psichici» in ambienti non istituzionali come gli “asili-scuola”, e dedicava alla psicologia applicata l’intero secondo volume del suo manuale di Psicologia sperimentale. Il suo successore alla cattedra romana, Mario Ponzo, passava dagli studi percettivi alla psicotecnica e alla psicologia del lavoro e dell’orientamento.
È interessante rilevare che la confluenza nella scienza psicologica di studiosi di formazione medica e di altri provenienti dalla filosofia si è realizzata soprattutto nella dimensione applicativa. Insieme ai tempi di reazione si studia la fatica del lavoratore; si associano studi sulle illusioni ottico-geometriche e sull’ipnosi e la psicologia forense; gli stessi ricercatori trattano la trasparenza fenomenica e la psicologia della testimonianza; i fenomeni sensoriali e la psicotecnica e la formazione professionale; la percezione visiva e la psicoanalisi; la cognizione/emozione e la psicologia giuridica e politica; la percezione causale e l’impatto delle tecnologie informatiche.
Il fondamento va trovato in una epistemologia e in una metodologia capaci di associare il rigore della sperimentazione al bisogno di rispondere alle esigenze di psicologia di una società sempre più complessa. E proprio la sinergia tra metodo sperimentale e applicazioni sul campo è il grande lascito che molti dei fondatori della psicologia moderna ci hanno regalato e di cui dovremmo oggi tenere conto.
Va superato lo stereotipo che la purezza e la validità della ricerca decrescono quanto più ci si allontana dal rigoroso controllo delle variabili, possibile in laboratorio: non lo pensavano i pionieri della psicologia e dovremmo evitarlo nell’attuale incontro della psicologia con le neuroscienze e con le scienze cognitive, inclusa l’intelligenza artificiale.
L’eredità ricevuta può aiutarci a ritrovare spunti utili per procedere nella direzione indicata dai nostri predecessori, costruendo una scienza psicologica che fa leva sul passato per contribuire al futuro della cultura e della società.
Santo Di Nuovo, professore emerito e docente di Psicologia cognitiva e neuroscienze nell’Università di Catania, è presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia. Tra i vari libri, ha scritto Prigionieri delle neuroscienze? (Giunti, 2014).
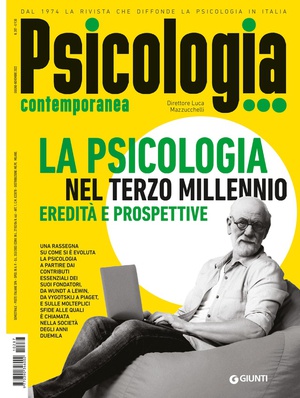
Questo articolo è di ed è presente nel numero 287 della rivista. Consulta la pagina dedicata alla rivista per trovare gli altri articoli presenti in questo numero. Clicca qui


