Comunicare, ossia saper mettere in comune
Secondo alcune teorie, noi comunichiamo con gli altri in modo analogo a come parliamo con noi stessi. Ma allora, più si prende coscienza e si padroneggia il linguaggio interiore e più si ottimizzano i rapporti con gli altri?
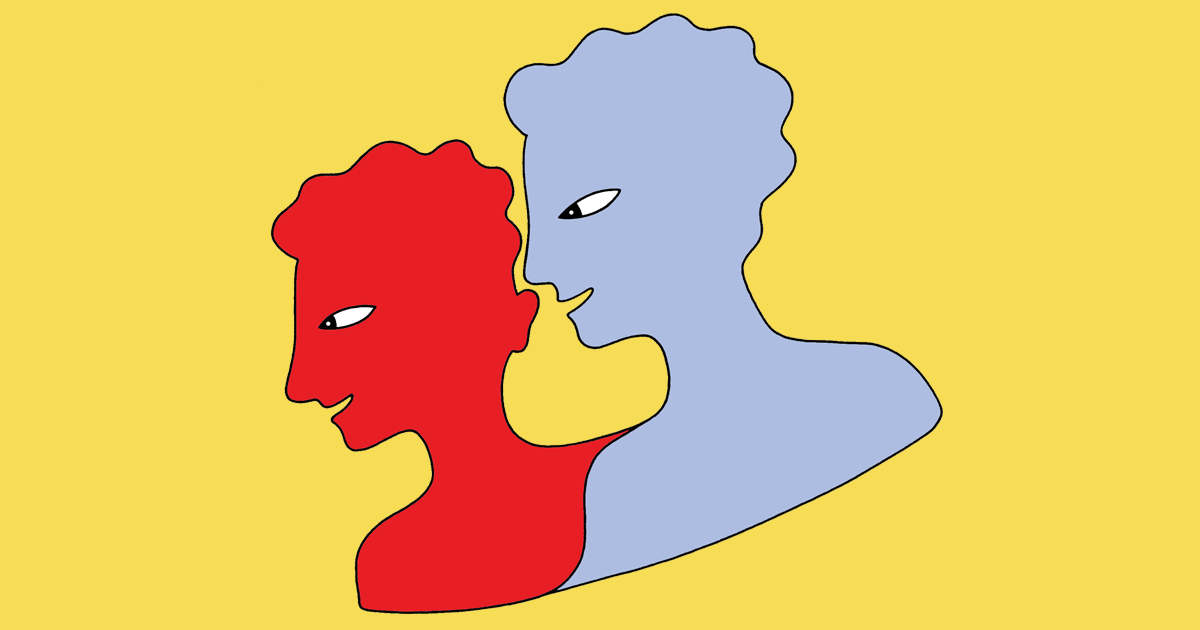
I corsi di comunicazione efficace sono tra i più presenti nel mondo della cosiddetta “crescita personale”; il mantra è sempre lo stesso: «La qualità della tua vita è direttamente proporzionale alla tua capacità di comunicare», cosa che potremmo discutere ma che colpisce per il suo fascino e la sua forza. Una cosa è certa: rispetto ai nostri antenati siamo costantemente inseriti in ambienti ad alto tasso di comunicazione, che sia un ambiente sociale fisico (quando la pandemia non ci impediva assembramenti di vario genere) o ambienti virtuali. Avere un profilo social è già di per sé un pezzo di comunicazione e, in base al luogo in cui hai il tuo profilo, comunichi cose molto diverse, anche se non ci passi un minuto del tuo tempo. Dopotutto ormai anche i muri sanno che «è impossibile non comunicare» e la nostra presenza o meno in un determinato luogo ha già di per sé il potere di classificarci in un qualche modo rispetto a un altro ambiente.
IL NOSTRO ISTINTO MIMETICO
È vero dunque che le abilità di comunicazione sono essenziali e sempre più richieste, al punto tale che oggi nelle maggiori aziende si conducono test e questionari per massimizzare queste “soft skills” e allo stesso tempo per cercare di valutarle. Comunicare essenzialmente significa “saper mettere in comune qualche cosa”, come sappiamo dal modello più antico della comunicazione, quello lineare di Shannon-Weaver, che vede lo scambio tra emittente e ricevente come mediato da un codice o da un insieme di codici. Più questi codici sono simili e più è probabile che il messaggio giunga da un luogo all’altro senza essere eccessivamente inquinato dal “rumore di fondo” che caratterizza ogni forma di interazione. Più codice e decodifica sono vicini e necessitano di poca energia e più il messaggio viene recepito facilmente e messo con maggiore semplicità in comune. Per fare un esempio classico, possiamo immaginare il codice come una lingua: è ovvio che due persone che parlano due idiomi differenti faranno molta fatica a comprendersi. Al contrario, due persone che parlano la stessa lingua non solo non fanno fatica, ma potrebbero, inconsapevolmente, vedere tale facilità come il segnale del fatto di stare avendo una buona comunicazione. Queste osservazioni le avevano già fatte gli antichi retori quando parlavano di “topos”, intendendo con il termine “argomento comune” da utilizzare per attrarre l’attenzione del pubblico e per metterci sullo stesso terreno. Se mi rivolgo a dei bambini, di certo non ricorrerò a frasi e metafore della politica, ma magari utilizzerò esempi tratti dai cartoni animati o dai videogiochi, ancora meglio se tali argomenti sono proprio quelli che interessano quella platea. Ciò è utile da tenere a mente quando prepariamo un discorso pubblico (uno speech, come viene definito oggi) e sappiamo che meno “frizioni cognitive” ci sono nel nostro messaggio e meglio verrà compreso e soprattutto “visto”.
Questo è un fenomeno molto particolare che è stato messo in luce anche dagli studi di Daniel Kahneman, il quale prese dei broker professionisti e fece loro valutare alcuni titoli finanziari differenti. Alcuni di questi avevano nomi alquanto difficili da leggere e pronunciare, mentre altri avevano nomi semplici e familiari: l’ipotesi dello studioso era che, nonostante i broker fossero preparati per analizzare con oculatezza i rendimenti, si sarebbero fatti distrarre dalla frizione cognitiva. E infatti molti di loro si fecero ingannare scegliendo le azioni con il nome più semplice da leggere e da ricordare, in una sorta di “effetto alone”. Questa cosa la sanno tutti gli studenti un po’ arguti, quando magari il professore, dando i compiti in classe, tuona ammonendo tutte le persone che hanno una brutta calligrafia. Chiunque abbia provato a correggere il compito di uno studente dalla scrittura illeggibile sa che tale fatica non si riversa esclusivamente nella forma, ma anche nella valutazione del contenuto. In altre parole, più è facile leggere ciò che lo studente ha scritto, più è scorrevole (quindi, non solo graficamente ma anche sintatticamente) e più è facile che il voto sia alto.
Quando racconto queste cose dal vivo la gente alza la mano e chiede: «Ok, quindi dovrei conoscere bene il mio pubblico e piegarmi alle loro esigenze? Ma non è una cosa troppo meccanica?». La risposta non è univoca, ma la cosa su cui vorrei portare la tua attenzione è che tale fenomeno è naturale in assenza di ostacoli. Quando parliamo con una persona che non conosciamo, il nostro tono di voce, la nostra prosodia si adattano a quelli del nostro interlocutore.
Se non mi credi, prova a fare questo semplice esercizio: prendi il tuo telefono e chiama un amico cercando di parlare con voce molto bassa, come se fossi in una biblioteca. Con alta probabilità, il tuo interlocutore si adatterà immediatamente al tuo tono, e anche se il tuo amico si trovasse in treno o allo stadio, tenderà a uniformare il proprio modo di parlare con il tuo. Non è detto che tutti ci riescano subito, ma, se intercorrono rispetto e ascolto, non appena l’altro sentirà il tuo tono tenderà a uniformarvisi.
L’imitazione è talmente importante, per noi esseri umani, da superare l’aspetto logico; ci ritroviamo a imitare gli altri perché questo ci ha garantito per millenni la sopravvivenza. Perciò se sei al supermercato e d’un tratto tutta la gente attorno a te scappa urlando, non hai bisogno di vedere che cosa sta accadendo. Anche tu ti metterai a correre.
Ci sono studi che hanno preso alcuni scimpanzé e li hanno confrontati con dei bambini per vedere la differenza nel modo di imitare. Lo sperimentatore mostrava sia alla scimmia che al bambino una scatola rompicapo all’interno della quale c’era un piccolo premio da raggiungere. Egli mostrava loro tutte le azioni necessarie per poter raggiungere il rinforzo, ma oltre a quelle essenziali ne inseriva di assolutamente casuali e inadatte allo scopo. Mentre la scimmia capiva subito quali erano le azioni da scartare, e quindi si limitava a fare le azioni corrette con il minimo dispendio energetico, il bambino imitava ogni comportamento, compresi quelli inutili. La conclusione è meno intuitiva di quanto appaia: non siamo meno intelligenti delle scimmie (forse sì, ma fino a una certa età), ma per noi esseri umani l’imitazione è più importante del premio stesso. Cioè il nostro istinto mimetico è più forte della logica; non copiamo solo i gesti necessari, ma tutte le azioni, che senza una precisa spiegazione potrebbero avere un qualche senso che non abbiamo ancora identificato.
IL DIALOGO CON NOI STESSI
Le tecniche per comunicare efficacemente risalgono dunque alla notte dei tempi, ma solo negli ultimi anni abbiamo assistito a una vera e propria esplosione di questo trend. Al punto che alcuni formatori hanno iniziato a propagandare un’idea assai seducente: il modo in cui comunichi all’esterno è simile al modo in cui comunichi con te stesso; pertanto, imparando e migliorando il tuo “linguaggio”, puoi migliorare non solo le relazioni con gli altri, ma soprattutto quelle con te stesso.
È davvero così? Il dialogo che tutti noi abbiamo con noi stessi è sicuramente specchio di ciò che ci accade e di come ci sentiamo, non a caso numerose psicopatologie sono strettamente legate ai pensieri ricorsivi (ruminazione). La depressione ne è un esempio emblematico, e in particolare le sue ricadute nelle situazioni più gravi sono spesso caratterizzate da un flusso costante di pensieri negativi, talché i vari approcci psicoterapeutici hanno elaborato svariate tecniche per riuscire a interromperlo, alcune più efficaci di altre. Se questa non fosse una rivista di psicologia, sicuramente ci sarebbe una fetta di lettori quasi inconsapevole di avere un dialogo interiore; per fortuna, non è il nostro caso, ma non tutti comunque sanno che tale parlottio è in un qualche modo efficace per i nostri obiettivi.
In uno studio condotto da Daniel Swigley e Gary Lupya si chiedeva a un gruppo di persone di cercare un prodotto all’interno di un supermercato. A una parte del gruppo è stato chiesto di farlo silenziosamente e ad un’altra parte del gruppo di farlo parlottando tra sé e sé, anche ad alta voce. Il secondo gruppo è stato significativamente più rapido e abile nel compito, dimostrando che il parlottio, anche quando è alto e ci fa imbarazzare («Sarò mica matto, dato che parlo da solo?»), è in realtà una sorta di modalità per aiutarci a fare le cose.
Esattamente come tutti i nostri contenuti mentali, anche il dialogo interiore è una specie di “mappa del mondo” che può aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi: saper rappresentare mentalmente un luogo è la chiave del successo di chi ha un buon senso dell’orientamento, e la stessa cosa accade con il linguaggio. Tuttavia questo, come già accennato, non è sempre produttivo; infatti, a quanto pare, gli stessi ricercatori hanno evidenziato che questo dialogo è utile quando abbiamo un obiettivo specifico, quando cerchiamo di mettere ordine tra i pensieri, e non in ogni istante della nostra vita. Infatti, quando siamo immersi in un’esperienza piacevole, in quegli stati che oggi chiamiamo “flow” (flusso), il nostro dialogo interiore si affievolisce lasciando spazio all’esperienza. Tutti abbiamo avuto la spiacevole sensazione di stare troppo dentro la nostra testa prima di prendere una qualche decisione, e di notare che più parlavamo con noi stessi e meno ci motivavamo all’azione, in una spirale di “paralisi dell’analisi”. Il nostro dialogo interiore è quindi una sorta di simulatore, un problem-solver che sta tutto il tempo a cercare di risolvere problemi, trovare alternative, giudicare ciò che facciamo, ciò che faremo e ciò che abbiamo fatto. Se durante una conversazione ci perdiamo in esso, saremo disconnessi dalla interazione, perderemo il filo del discorso e non riusciremo ad ascoltare il nostro interlocutore. Insomma, quando smettiamo di utilizzare questo dialogo esso “ci usa” in un qualche senso, noi ci identifichiamo con esso, e le conseguenze non sono sempre piacevoli.
LA MAPPA E IL TERRITORIO: OLTRE IL RIMUGINIO
Il dialogo interiore è diverso da quello che usiamo mentre parliamo? Da un punto di vista formale, sicuramente sì, non ha una vera onda acustica, è spesso disordinato, parla solo di noi stessi (siamo naturalmente egocentrici), ma, a quanto pare, non è così differente se proviamo a valutarlo attraverso strumenti empirici. Il noto linguista Andrea Moro, insieme alla sua équipe, ha svolto alcuni studi in tal senso: ha chiesto a delle persone di ripetere mentalmente alcune frasi e ha registrato l’attività elettrica delle aree coinvolte nel cervello. Ha scoperto così che lo spettro grafico, l’onda prodotta dall’elettricità, era del tutto sovrapponibile all’onda presente quando si produce verbalmente quella stessa identica frase. In altre parole, è come se esistesse una sorta di corrispondenza tra il linguaggio verbale prodotto dalla nostra bocca e quello che invece produciamo nell’intimità della nostra soggettività.
Ciò significa che sono la stessa cosa? Certamente no, però prova che esiste una qualche similitudine che andrebbe ulteriormente indagata magari proprio con persone che hanno problemi emotivi legati al dialogo interiore, aspetto che tecnicamente chiamiamo “rimuginio”. Questo aspetto è noto in psicologia clinica perché «accomuna molti disturbi dell’umore ed è caratterizzato dalla concatenazione di pensieri con valenza negativa e relativamente incontrollabili, che attiviamo nel tentativo di mettere in moto un problem-solving mentale su una questione dal risultato incerto» (Borkovec et al., 1983). Quando Borkovec iniziò a studiare il rimuginio fu quasi per caso: egli era un ricercatore che indagava il sonno e che in particolare si stava chiedendo cosa generasse insonnia nei suoi soggetti. Vi erano numerose ipotesi su tale fenomeno, ma ciò su cui cadde la sua attenzione fu proprio questo stile di pensiero: le persone tendevano ad arrovellarsi tra i pensieri nel tentativo di addormentarsi. Non a caso, quando diciamo di poter fare “sogni tranquilli” spesso ci riferiamo al fatto di avere la coscienza pulita, di non aver lasciato nulla in sospeso, perché è proprio questo ciò che accade: pensiamo e ripensiamo agli avvenimenti della nostra vita nel tentativo di risolverli o capirli. Il nostro simulatore, come un bravo computer, scandaglia tutte le possibili situazioni e soluzioni a problemi più o meno decidibili e quando trova quello indecidibile (su cui è cioè impossibile trovare una risposta precisa) vi s’incaglia e gira vuoto come un nastro rotto.
È come se questo dialogo, invece di fare il proprio dovere – aiutarci a gestire la nostra vita, risolvere problemi e darci alternative nelle scelte –, si trasformasse in un aguzzino. Invece di usare il simulatore come tale ci identifichiamo con la simulazione al punto da incastrarci: lo stesso fenomeno di identificazione e disidentificazione che avviene nella pratica della meditazione, messo sul banco della psicologia clinica già diversi anni fa da Roberto Assagioli e oggi tornato in auge con le intuizioni e le metodiche dei teorici della terza ondata della terapia cognitivo-comportamentale. Dove il problema non sta più solo nel contenuto dei pensieri, ma in come li gestiamo. Per citare un noto aforisma attribuito a Epitteto – «Noi non soffriamo per gli eventi che ci accadono, ma per le opinioni che abbiamo su tali eventi» –, potremmo dire che non è tanto l’opinione in sé a contare, ma quanto vi crediamo.
Ora, non vorrei essere frainteso: è chiaro che il contenuto di ciò che ci diciamo è importante, ma lo è altrettanto il tasso della nostra identificazione in esso. Tutti abbiamo anche contenuti mentali non troppo lusinghieri: una persona ci fa arrabbiare e possiamo arrivare a immaginare azioni molto forti contro di lei; tuttavia non è detto che si debba metterle in atto, né è detto che quelli siano i nostri “desideri inconsci”. A volte è solo una delle tante opzioni mostrateci dal simulatore, ma non è detto che dobbiamo metterla in atto.
Questa prospettiva mi piace molto perché ci libera da una prigione nella quale tutti tendiamo a bloccarci, che è quella del pensiero, una sorta di reificazione di ciò che ci salta in mente. Ma se ci sediamo, come descritto da alcuni esempi di meditazione, possiamo facilmente renderci conto che spesso pensiamo a “tutto e il contrario di tutto”: questo non perché siamo matti, ma perché è la natura stessa di tale simulatore a fare varie ipotesi sul mondo. Il problema è quando iniziamo a credere che le nostre ipotesi siano realmente il mondo; quando confondiamo la “mappa” e il “territorio”.
Tu sei molto di più dei tuoi pensieri, sei il luogo in cui sorgono e tramontano migliaia di ipotesi differenti sul mondo; ciò che ti determina non sono tali simulazioni, ma cosa tu ne fai, cioè le azioni che intraprendi. Certo, i pensieri e il chiacchiericcio interiore ti influenzano, ma se inizi a vederli come “ipotesi sul mondo”, appunto, potrai iniziare a fare spazio per tutti quei contenuti mentali e gradualmente renderti conto che puoi decidere di tradurli in pratica o meno sulla base di ciò che è davvero importante per te in quel momento.
Gennaro Romagnoli, psicologo e psicoterapeuta, è autore di Psinel, il podcast di psicologia e crescita personale più ascoltato in Italia. Si occupa di divulgazione online dal 2007.
Bibliografia
Borkovec T. D., Robinson E., Pruzinsky T., DePree J. A. (1983), «Preliminary exploration of worry: Some characteristics and processes», Behaviour Research and Therapy,
21, 9-16.

Questo articolo è di ed è presente nel numero 285 della rivista. Consulta la pagina dedicata alla rivista per trovare gli altri articoli presenti in questo numero. Clicca qui


